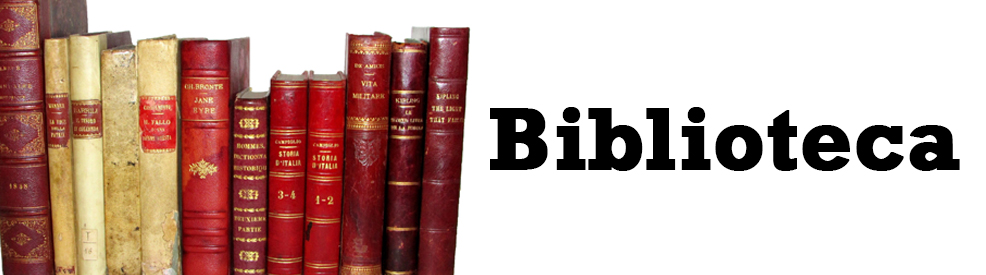Sport e fumetti: la storia in Italia
Lo sport inglobato nel fumetto è senz’altro, in Italia, un’invenzione fascista. Né poteva essere altrimenti se solo si pensa alla grande valenza politica assegnata allo sport da tutti i grandi totalitarismi del Novecento, a cominciare proprio dal suo primo modello paradigmatico: il fascismo italiano. Lo sport doveva formare l’”uomo nuovo” e, a questo scopo, si doveva partire dall’educazione giovanile monopolisticamente organizzata all’interno dell’Opera nazionale Balilla e successivamente dalla Gioventù italiana del Littorio. Un’educazione virile e guerriera che non poteva prescindere dalle attività sportive promosse a scuola, nelle palestre e negli stadi, ma pure inculcata attraverso le forme più accattivanti delle tavole dei comics giovanili.
Dopo che nel 1938 il ministero della Cultura Popolare (Minculpop) prese a censurare la pubblicazione dei fumetti statunitensi, i periodici per ragazzi iniziarono ad ospitare con sempre maggiore frequenza questo genere di storie a puntate debitamente sottoposte a un rigido controllo ideologico. “L’Audace”, “Il Vittorioso“, “L’Intrepido”, “Corrierino” ecc. si sostituirono alla fumettistica nordamericana e, tra il 1938 e il 1943, si affermò definitivamente il fumetto giovanile all’italiana, o meglio d’impronta smaccatamente fascista impregnato com’era di retorica patriottarda e sciovinismo nazionalistico. Una stagione fumettistica che, nella costruzione avventurosa di eroi e miti, utili alla propaganda e alla cattura del consenso, diede un notevole spazio anche allo sport. E se il personaggio di “Motorino”, creato nel 1934 sulle pagine del “Corrierino” da Carmelo Silva, può essere considerato il primo sportivo del fumetto italiano, seguito poi, sulle stesse colonne, da “Pin Focoso” (1941) disegnato da una grande firma quale Walter Molino, a farla da padrone nelle storie era anche allora, ovviamente, soprattutto il calcio (si veda in proposito l’efficace saggio di Juri Meda “Atleti nel pallone. Fumetti, fascismo e sport”, in “Lancillotto e Nausica”, n. 1-2-3, pp. 42-59).
Calcio che si affidò subito alla brillante matita di Benito Jacovitti, il quale, su “Forza Pippo”, nel 1940 raccontava col suo segno inconfondibile una vivace partita di pallone. In precedenza Orfeo Toppi, su “Il giornale di Cino e Franco” del maggio-giugno 1937, aveva dedicato le sue strisce a “Il Re dei calciatori”, mentre, spaziando su un arco più ampio di discipline, a Silvano Craveri, su “Il Vittorioso” del gennaio-febbraio 1939, dobbiamo tavole di podismo, sci, motonautica e ippica ambientate all’interno della sua fortunata “Zoolandia”. Il più celebre protagonista dei fumetti “autarchici” di quegli anni, spesso impegnato anche in avventure di respiro sportivo, va però indubbiamente considerato “Dick Fulmine”, al secolo “Dick Pestalozza”. Le sue mirabolanti imprese, prima di passare sul “Corrierino”, comparvero agli inizi su “Albogiornale” (1938) e nacquero da un’idea partorita al tavolino del milanese “Bar degli Sportivi” dall’affiatata coppia Vincenzo Baggioli (soggettista) e Carlo Cossio (disegnatore). Nell’anno dell’embargo decretato dal Minculpop alle vignette d’oltreoceano, i due crearono per l’appunto la risposta fascista ai super-eroi americani. E Dick Fulmine, a ben vedere, ricordava non tanto alla lontana il “gigante buono” del pugilato Primo Carnera. Tant’è non è un caso che, caduto il regime, dall’aprile 1947 al marzo 1950, per un insieme di 97 numeri, in edicola si potessero trovare gli “Albi Carnera”, ossia una raccolta a fumetti, nel solco del successo di “Dick Fulmine,” realizzata da Mario Uggeri e Tristano Torelli. Un anno prima, nel 1946, il calcio era invece tornato ad occupare i numeri del “Vittorioso” col lungo “cineromanzo”, “Goal”, dovuto a un altro maestro del fumetto sportivo italiano: Silvani. Una storia, quella di Silvani, che narrava d’un gruppo di lavoratori italiani emigrati in California e impegnati nella difficile sfida a una squadra di calcio locale. Dunque quella dello sport che si coniuga con il fumetto è una storia che parte da lontano e, rinnovandosi nei contenuti, continua tuttora. Pensiamo ad esempio alle contaminazioni che si rintracciano anche in alcuni numeri di “Tex” (“La corsa della freccia”, gennaio 1977) o di “Zagor” (“La corsa delle sette frecce”, luglio 1990); a Grazia Nidasio (l’autrice di “Valentina Melaverde & C”) che, sul “Corriere dei Ragazzi” del 26 marzo 1972, intitolava una sua serie di strisce “Una partita movimentata”; a “Diabolik” di Angela e Luciana Giussani, che il 10 giugno 1991 fanno cimentare in una spericolata avventura alpinistica. Per arrivare, oggi, al progressivo affermarsi della “graphic novel”. In questo specifico una segnalazione particolare meritano “Pesi massimi. Storie di sport razzismi sfide” (Sinnos, 2014) di Federico Appel (rivisitazione a fumetti delle vicende di campioni “impegnati” quali Muhammad Alì, Jesse Owens, Gino Bartali, John Carlos, Tommie Smith, Peter Norman, Barlos Caszely, Arthur Ashe, François Pienaar), nonché “Le macerie del dopismo leninismo” di Cinzia Leone, ospitata su “La Lettura” del “Corriere della sera” del 22 novembre 1915. E da ultima, buon’ultima l’Uisp, che già sul “Discobolo” del settembre (pp. 2-10) e ottobre (pp. 45-55) 1981 aveva dedicato al tema una corposa analisi di Stefano Cristante e Luca Raffaelli, e più di recente ha garantito il suo pieno sostegno al lavoro di Luca Ferrara e Antonio Recupero “Dorando Pietri. Una storia di cuore e di gambe” (2016).
NOTIZIE DA UISP NAZIONALE