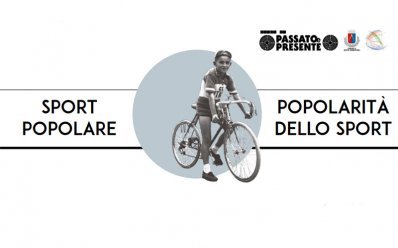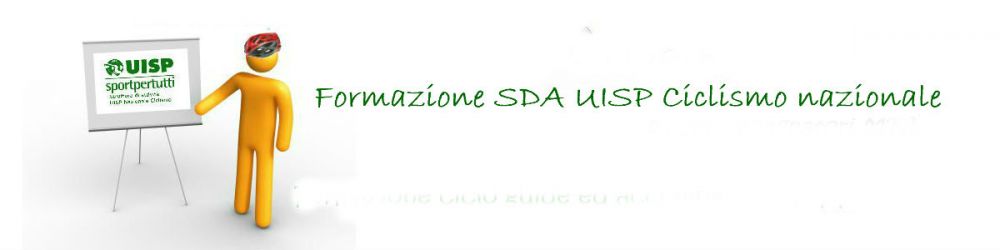Sport popolare e popolarità dello sport: la storia di un fenomeno
Pubblichiamo alcuni passaggi dell'editoriale dell'ultimo numero di "Passato e presente", dedicato allo sport popolare. Di P. Causarano, F. Tacchi, L. Venuti(fonte UISP Nazionale)
Pietro Causarano è professore associato di Storia dell’educazione (Università di Firenze) e insieme a Francesca Tacchi e Lorenzo Venuti è autore del numero monografico della rivista "Passato e presente", 2020 n. 111 dedicato a "Sport popolare/popolarità dello sport". Vi presentiamo alcuni passaggi dell'introduzione al volume:
L’identificazione con lo sport e le sue figure rappresentative è profondamente radicata nella sensibilità collettiva e nella quotidianità di un larghissimo numero di persone, come ha dimostrato nel 2018 l’ondata di emozione generalizzata che ha accolto, non solo in Italia, la scomparsa del calciatore Davide Astori. Eventi ancor più drammatici per la loro dimensione di tragedia collettiva, come gli incidenti aerei che coinvolsero il Torino (1949) e il Manchester United (1958) nel dopoguerra, già segnalavano questa identificazione popolare dell’opinione pubblica con gli eroi sportivi, ben al di là degli appassionati e dei tifosi. Lo sport come spettacolo e veicolo di sentimenti e passioni ormai da lungo tempo occupa un posto centrale nella nostra vita sociale, benché oggi in forme spesso molto diverse da un passato ancora prossimo.
L’associazionismo sportivo è una delle articolazioni intermedie della sociabilità più rappresentative del nostro mondo e del nostro tempo, anche sul piano quantitativo, rispetto ad altre forme di aggregazione ereditate dal ’900 e sempre più declinanti. Nello sport, non in tutto certamente, possiamo individuare uno dei settori economici oggi più redditizi e degni di investimento da parte del capitale finanziario internazionale, tanto da modificarne spesso ormai caratteristiche di esercizio e fruizione. In altri termini gli sport costituiscono ormai una sfera di attività sociale e una pratica culturale da prendere con la massima serietà non solo da parte di chi lo segue o lo pratica, ma anche da parte dello storico, come ricordava Richard D. Mandell in Sport. A Cultural History del 1984. Enormi passi in avanti sono stati fatti rispetto ai seminali studi di sociologia storica portati avanti da Norbert Elias negli anni ’60 (poi raccolti con altri saggi successivi in Quest for Excitement: Sport and Leisure in the Civilising Process, pubblicato con il suo allievo Eric Dunning nel 1986), là dove dimostrava che il loisir, i passatempi e in particolare gli sport non erano soltanto il lato dilettevole della vita, da coltivare eruditamente nella sfera ristretta dello specialista, ma qualcosa di più significativo e cogente nel rappresentare la realtà sociale complessiva attraverso le esperienze quotidiane. Ancor più che nel quasi coevo lavoro di Roger Caillois su Les jeux et les hommes (1958, poi ampliato nel 1967), o in quello precedente di Johan Huizinga del 1938, Homo ludens, per Elias lo sport è lo specchio di come si struttura e funziona una società: la vita seria è speculare ai suoi passatempi e alla sua sfera ludica; questi ultimi si nutrono degli stessi meccanismi di regolazione e autoregolazione dell’altra, pur funzionando in modo esplicitamente e legittimamente diverso, garantendo specifiche forme di identificazione.
Il processo di “sportivizzazione” del loisir (l’invenzione dello sport, si potrebbe dire) che caratterizza per prime le élites britanniche fra fine ’700 e soprattutto ’800, ne è un esempio. La trasformazione in sport di quelle attività ludico-competitive che prevedono l’uso del corpo e della forza, da sempre presenti nelle società umane, segna una decisiva spinta alla specializzazione e istituzionalizzazione per una pratica che attiene alla vita quotidiana delle società moderne, sempre più urbanizzate e industrializzate. Si tratta di un fenomeno diffusosi poi rapidamente su scala planetaria, uno dei primi esempi di globalizzazione normativa. Rappresenta anche un esplicito riconoscimento della funzione sociale dello sport e quindi indirettamente della sua centralità crescente rispetto ad altre sfere della vita collettiva nella misura in cui coinvolge tutti gli strati sociali e culture diverse, come segnalava nel 1978 Allen Guttmann nel classico di storia dello sport From Ritual to Record. The Nature of Modern Sports.
Gli sport hanno raggiunto così una larga popolarità – non omogenea – che si riscontra non solo nel numero dei praticanti e degli appassionati, ma anche e soprattutto dei fruitori di uno spettacolo capace di mobilitare, in modo più o meno diretto, risorse finanziarie e simboliche impressionanti e di farle entrare in circolazione interagendo simbioticamente con la comunicazione di massa e la politica: dalle esperienze ideologiche del ’900 alla cittadinanza e al Welfare del dopoguerra e al professionismo come esito individuale della specializzazione o come risorsa economica spettacolare della collettività, lo sport ha investito quote crescenti del nostro tempo, della nostra immaginazione, della nostra vita di relazione.
Se larga parte dei praticanti restano nella sfera del dilettantismo appassionato, lo sport come spettacolo inevitabilmente si è costruito sulla selezione dei più abili nell’uso competente della forza in ogni singola disciplina e quindi attorno a percorsi, espliciti o impliciti, di professionalizzazione differenziati nel tempo. In altri termini, il professionismo ha fatto degli sport uno spettacolo tanto quanto la spettacolarizzazione dello sport ha aperto la strada alla professionalizzazione della pratica. Lo sport, in origine passatempo delle élites, si è “popolarizzato” diffondendosi socialmente e geograficamente fra fine ’800 e la prima metà del ’900 e divenendo contestualmente, nelle sue forme più spettacolari, anche una piacevole prospettiva di lavoro; le forme di adesione popolare a questa pratica sono profondamente mutate nel tempo, evidenziando fratture, rispecchiandone – e modificandone – le rappresentazioni sociali. Un’attività che è liberamente autocentrata sul soggetto che la pratica, che privilegia attraverso la prestazione la dimensione dell’individuo, in realtà ha funzionato come collettore di grandi proiezioni collettive. Gli storici, più degli scienziati sociali, si sono concentrati sulla stretta relazione emersa nel corso dell’800 e del ’900 fra identità sociali (e di classe), processi di nazionalizzazione e politica di massa. L’uso pubblico dello sport, evidenziato soprattutto dai fascismi e dai regimi socialisti, è stato centrale nella storiografia in questo campo. Come dimostrano i lavori di Felice Fabrizio, questo approccio è stato anche un canale per legittimare un campo di ricerca che a lungo è stato considerato fatuo e poco significativo dalla storiografia in Italia, fino ad anni abbastanza recenti e al rinnovamento operato dagli studi seminali di Stefano Pivato. La partecipazione sportiva come vettore di consenso passivo negli anni ’20-’30 del ’900 o nel secondo dopoguerra oltrecortina, non esaurisce però lo spettro complesso del perché si fa o si segue uno sport, esattamente come non era soddisfacente la rappresentazione igienista e moralistica che accomunava circolarmente il discorso su sport e educazione fisica tra ’800 e ’900. Anzi, il disciplinamento sociale attraverso lo sport ha rappresentato un terreno di confronto fra percezioni e modelli culturali e anche politici diversi per tutto il secolo scorso.
In quale misura dunque lo sport come fenomeno diffuso è “popolare”? Quali sono i diversi significati e le plurime strutture di senso che sono stati attribuiti nel tempo al carattere popolare degli sport? Perché alcuni sport sono più popolari di altri? Perché oggi assistiamo a un ritorno di attenzione per lo “sport popolare”, contrapposto – ideologicamente e politicamente – non solo alla “popolarità” dello sport come business spettacolare, in un senso diverso dalla semplice dicotomia dilettantismo/professionismo, ma anche lontano dalla tradizionale sociabilità espressa dalle culture di classe e in genere politiche e confessionali del secolo scorso? La storia dello sport in Italia, rispetto ancora a qualche anno fa, mostra oggi segni di crescente vitalità e di dialogo con la dimensione internazionale sul piano della ricerca storiografica e del confronto scientifico. Accanto alla più istituzionale Società Italiana di Storia dello Sport, attiva dal 2004, e alla pionieristica rivista «Lancillotto e Nausica» (1984), orientata su uno spettro temporale dell’idea di sport quasi meta-storica, oggi si affiancano altre esperienze editoriali, come «Storia dello sport. Rivista di studi contemporanei» (2019). «Passato e presente» ha ritenuto che vi fosse lo spazio per riflettere sullo sport, sia de visu sia successivamente in un numero monografico della rivista. Nel novembre 2019 abbiamo così organizzato – grazie all’apporto dell’associazione Amici di Passato e presente (APeP) e con il patrocinio e il sostegno finanziario dei dipartimenti Sagas e Forlilpsi dell’Università di Firenze – due giornate di studio su Sport popolare, popolarità dello sport1, per far dialogare – nello spirito dell’associazione – la ricerca storica con le esperienze concrete di pratica sportiva del presente e con il mondo della scuola....
... Proprio per cercare di stimolare ulteriormente il dibattito e permettere anche ai non addetti ai lavori di apprezzare la complessità dei temi trattati, il sommario del numero rispecchia solo in parte la tradizionale scansione delle rubriche di «Passato e presente», e anticipa la parte di riflessione sullo stato della ricerca. Si apre infatti con un «focus» del sociologo Nicola Porro sul rapporto fra sport e cittadinanza attiva, identificandone il nesso originale e riassumendone le possibili declinazioni.
Seguono due ampie rassegne che delineano alcuni dei temi affrontati nel numero. Andrea Zorzi si interroga sulla metodologia della storia dello sport, sottolineando che, per arricchire il contesto in cui questo si colloca, le ricerche storiche non dovrebbero sacrificare la dimensione tattico-sportiva e agonistica, che permette allo sport (in questo caso il calcio) di divenire popolare. Nicola Sbetti ripercorre invece la storiografia della storia dello sport, concentrandosi sulla dimensione popolare ed evidenziandone lo stato dell’arte.
....
Lo sport, e in particolare il calcio, fonda il proprio successo sulla presenza e sulla mobilitazione dei tifosi, come ricordano i due successivi contributi. Fabien Archambault analizza l’articolo sul derby Roma-Lazio pubblicato nel 1957 su «l’Unità» da Pier Paolo Pasolini, primo intellettuale a intervenire in un quotidiano generalista su temi sportivi e a presentare e leggere in maniera positiva la cultura del tifo. E sulla mobilitazione, non solo comunitaria ma anche politica, dei supporter Gianni Silei presenta un cantiere di ricerca sul calcio inglese, a partire dal caso del Charlton Athletic fra gli anni ’80 e ’90, che conferma l’importanza di un tema attuale quale quello degli impianti sportivi, degli stadi.
BIKE CARD Tutorial
La Direzione Nazionale UISP ha comunicato a tutti i livelli che in data 01 febbraio 2023 è stato sottoscritto, nel rispetto delle prerogative di ciascun organismo, il rinnovo della Convenzione UISP - FCI per il 2023
Hanno sottoscritto la convenzione 2023 i seguenti Enti: US ACLI, CSAIN, AICS, LIBERTAS, CSEN, ACSI, CSI, UISP e ASI (con Bike Card). I loro tesserati possono regolarmente partecipare alle gare e alle manifestazioni amatoriali e cicloturistiche della FCI.
Dal 09/02/23 OPES ha sottoscritto la convenzione 2023. I loro tesserati, in possesso della Bike Card, possono regolarmente partecipare alle gare e alle manifestazioni amatoriali e cicloturistiche della FCI.
Per agevolare le procedure, è possibile verificare la presenza del ciclista nel database della Bike Card, accedendo alla procedura on line direttamente da questo link oppure tramite l’immagine sottostante