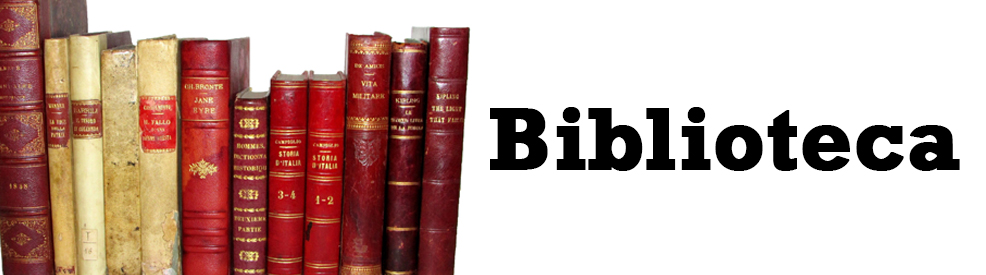E' scomparso Klaus Heinemann, tra i fondatori della sociologia sportiva
Il ricordo di Nicola Porro che contribuì insieme al sociologo tedesco al libro di Gianmario Missaglia, "Il baro e il guastafeste"
Il 23 gennaio è scomparso Klaus Heinemann, fra i padri fondatori della sociologia dello sport europea. Nato in Germania, dove ha completato la propria formazione, ha conseguito il dottorato di ricerca in fisica sperimentale presso l’università di Tubinga. Ha lavorato per molti anni alla NASA, UCLA, come ricercatore nell’ambito della scienza dei materiali, ed è stato professore ricercatore alla Stanford University. È stato il fondatore e presidente di una società che si occupa di ricerca scientifica in fluidodinamica computazionale, sviluppo dei materiali e nanotecnologia sotto contratto NASA. Per vari decenni Heinemann si è adoperato per comporre quella che viene comunemente percepita come divergenza fra scienza e spiritualità, e tiene conferenze sull’espansione della percezione.
Nicola Porro, sociologo e professore all'Università di Cassino e del Lazio meridionale, ha ricordato il collega scomparso con queste parole: "Con lui perdiamo un sociologo di eccellenza, uno studioso esemplare, una persona di grandi qualità umane e un caro amico".
Heinemann e Porro hanno entrambi contribuito al libro di Gianmario Missaglia nel 1998, "Il baro e il guastafeste": in particolare lo studioso tedesco ha curato, insieme a Nuria Puig, il capitolo "Trasformazioni dei modelli di sviluppo sportivo nelle società sviluppate".
"L'aspetto più rilevante del sistema sportivo moderno è la sua diversificazione. Lo sport non è più un sistema autonomo ma è diventato un sistema aperto, con scarsa specificità e strettamente collegato ad altri sistemi, come ad esempio quello eocnonico, educativo, politico... Lo sport tradizionale era un'unità omogenea ed una entità autonoma che non risponde più alla realtà attuale del fenomeno. Si associava ad obiettivi chiaramente definiti nell'ambito di regolamentazioni perfettamente chiare. L'idea era sempre quella di raggiungere certi scopi seguendo una preparazione disciplinata e continua. Sport significava competizione e tendenza verso una meta o traguardo. Vi era uniformità perfino nel sistema dei valori. Legava valori individuali come il cameratismo, lo spirito comunitario, la solidarietà con la filosofia del risultato, lo svago, la squadra, la competizione... L'esperienza del gioco e la logica del risultato erano, di conseguenza, sempre inseparabili. L'ambiente nel quale si poteva svolgere questo tipo di sport era il club sportivo, caratterizzati da lavoro volontario, struttura decisionale democraticam indipendenza, simboli di identificazione. Infine, sia per il tipo di attività che offriva, sia per l'ambiente organizzativo che le accoglieva, questo sport dava origine a processi selettivi e di emarginazione. Riuscivano ad integrarso solo quelle persone le cui possibilità di azione e i cui interessi coincidevano con le sue carateristiche fondamentali. Era un terreno limitato ai ragazzi della classe media e alta. Più attraente per i giovani che per gli adulti, per gli uomini che per le donne. La situazione è cambiata. L'analisi della popolazione che pratica lo sport e delle organizzazioni sportive non corrisponde più alla descrizione effettuata. C'è stata una rottura del modello tradizionale.
Lo sport moderno è caratterizzato da un processo di differenziazione crescente. Non esiste più un solo modello che riunisce le sue principali caratteristiche. .... Così il modello competitivo contiene elementi espressivi, quello strumentale può arrivare ad associarsi al modello spettacolo. L'importante è che nel loro complesso rappresentino manifestazioni reali".