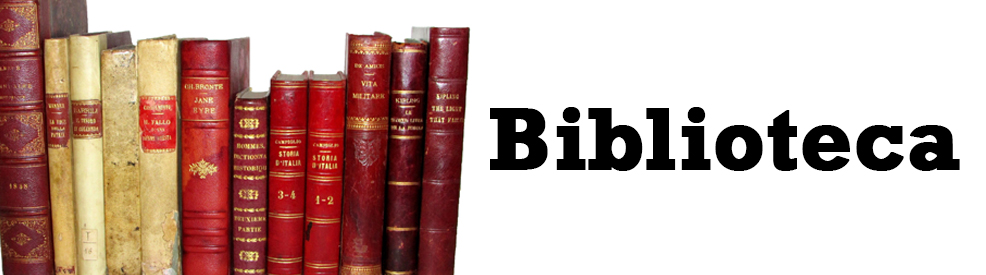Olimpiadi: lo sport tra storia e politica
Le riflessioni dello storico Segio Giuntini e del sociologo Nicola Porro. Lo sport è la prosecuzione della politica con altri mezziSergio Giuntini, giornalista e storico dello sport, ha scritto una approfondita riflessione sul legame tra sport olimpico e evoluzione della società e della politica, pubblicata sul numero 3 della rivista Stile Libero. Ve ne proponiamo uno stralcio.
"Lo sport, parafrasando Karl Von Klausevitz - scrive Giuntini - ha spesso costituito come la guerra una "prosecuzione della politica con altri mezzi". Una verità scomoda, forse spiacevole, ma difficilmente contestabile. Resa fin più manifesta dall'ipocrita neutralismo/politicismo mistificante con il quale le massime istituzioni sportive hanno cercato, da De Coubertin a Rogge, di mascherare questa realtà. Sport e politica, sport e ideologia rappresentano un binomio inscindibile, caratterizzato - su vasta scala e a livello regionale - dalla contaminazione profonda fra questi elementi. Si pensi a quale efficace metafora (o pallottoliere) siano state le Olimpiadi nell'era della Guerra Fredda e dello scontro totale e totalizzante fra Est comunista e Ovest capitalista. Allo straordinario palcoscenico offerto dai Giochi olimpici, per l'affermazione d'una propria orgogliosa identità, ai paesi asiatici e africani appena usciti dal colonialismo. Per quanto tempo, fin dal 1896 della rinascita olimpica moderna, il nazionalismo si sia impadronito del cosiddetto 'spirito olimpico'".
"Insomma, l'Olimpiade di cui sta per tenersi a luglio-agosto 2012 un'altra imponente edizione a Londra, si presta in ogni frangente a una riflessione sull'autentico significato dello sport, spogliato di tutti gli apparati simbolici e valoriali del grande rito. Ai nostri giorni, fra l'altro, sempre più e solo mediatici e commerciali. All'arena globale dello sport, in relazione ai conflitti politici e al complesso tessuto dei rapporti internazionali, serve dunque proseguire a guardare per cercar di capire da che parte va il mondo".
"Tuttavia solo una buona conoscenza del fenomeno sportivo novecentesco aiuta a coglierne appieno la continuità sulla 'lunga durata' della storia. Limitandoci all'olimpismo, interverremo perciò qui su due casi paradigmatici. Non già sulla scia ininterrotta e assai nota di boicottaggi che vanno dal 1976 al 1984 (Montreal, Mosca, Los Angeles), né sulle altrettanto accuratamente studiate Olimpiadi hitleriane del 1936 a Berlino, bensì su quelle del 1932 e del 1968. Olimpiadi meno boicottate, ma se possibile ancor più duramente avversate e contestate".
“Gli Stati investono sulle Olmpiadi per questioni simboliche, di prestigio. Infatti, se ripercorriamo la storia del movimento olimpico vediamo che vengono sempre celebrate a coronamento di un processo di legittimazione simbolico del potere politico. Basta pensare a Berlino 1936, Barcellona 1992, che celebrò il ritorno della Spagna nel sistema democratico, o alla Cina del 2008, per la prima volta organizzatrice di un evento su scala globale. Le Olimpiadi hanno sempre scandito dei passaggi importanti nella vita politica mondiale. Le Olimpiadi classiche, dell’antica Grecia, non erano grandi eventi agonistici, erano competizioni celebrate dai rampolli delle aristocrazie delle polis, avevano valore simbolico e politico. De Coubertin prende a prestito il tema falsificandolo, legandolo a nobili intenti politici e umanitari: “trasferire il conflitto delle nazioni sul territorio simbolico dello sport”. Fa un’invenzione della tradizione".
“Secondo me nel futuro avremo due traiettorie nel movimento olimpico: da una parte i paesi emergenti, che continueranno ad investire capitali per legittimare simbolicamente il loro ruolo politico internazionale, dall’altra credo che la formula dell’unico paese organizzatore potrebbe declinare, penso ad esempio a paesi che si consorziano per l’organizzazione”.
Il sipario internazionale è sempre stata un’occasione per esprimere critiche al sistema. “Si sovrappongono due questioni diverse: la protesta che vuol approfittare, nel senso buono, dell’evento per portare sotto gli occhi del mondo, grazie alla comunicazione planetaria, un problema, come è stato per il Tibet e l’Ucraina. Questo è possibile, ma non lo credo probabile: la Gran Bretagna non mi pare un bersaglio politicamente sensibile come la Cina o alcuni paesi post socialisti. Un’altra cosa sono gli eventi terroristici, purtroppo le Olimpiadi hanno già conosciuto fatti del genere, è un elemento che è difficile prevedere, è una possibilità, ma sicuramente saranno state prese tutte le misure più efficaci”.
La spedizione italiana conta circa 250 atleti, cosa significa per un paese la classifica finale? “Il singolo evento olimpico significa abbastanza poco: il medagliere ha un senso per monitorare l’efficienza del sistema che organizza, quindi in serie storica. L’attuale posizionamento italiano è eccellente, siamo tra le dieci potenze olimpiche”.
“In conclusione non ridurrei le Olimpiadi a un fenomeno di panem et circenses, non vengono organizzate per distrarre l’opinione pubblica. La raccomandazione è di non perdere mai il senso della misura e la visione critica delle cose, ricordando che dietro le Olimpiadi c’è qualcosa che va oltre la manifestazione sportiva”.