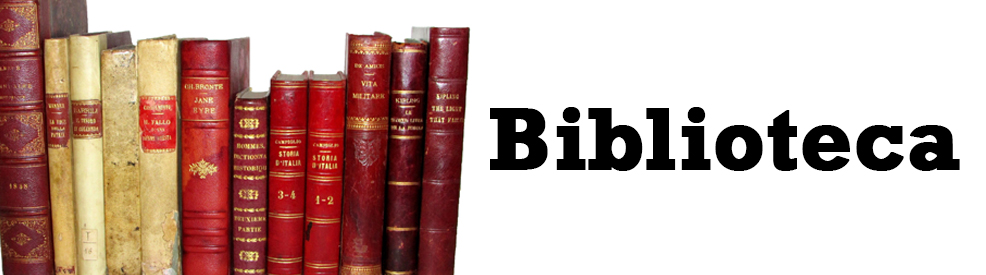Storie che nessuno vuole sentire: gli insegnamenti del progetto SIC!
Nell'articolo di Davide Valeri, dati e testimonianze sulle discriminazioni nello sport italiano, frutto della ricerca del progetto SIC! promosso dall'Uisp
Davide Valeri, sociologo, è intervenuto sullo scorso numero di Uispress a proposito della polemica giornalistica sull'italianità di Sinner, con un articolo che ha superato le 13.000 visualizzazioni. Valeri in quanto curatore della ricerca del progetto Sic!-Sport Integrazione Coesione promosso dall'Uisp. Nel suo blog ha pubblicato un articolo che raccoglie gli elementi qualificanti di questo lavoro, per cercare di rispondere alla domanda del titolo: "Chi può giocare?". La risposta che ne emerge è che il razzismo non è un’emergenza, è una struttura; lo sport femminile non esiste (secondo chi decide i budget); ci sono corpi che non contano. In conclusione, "il cambiamento è possibile, ma non automatico".
Leggi l'articolo di Davide Valeri
Ho lavorato al progetto SIC! – Sport, Integrazione, Coesione, promosso da Uisp in collaborazione con UNAR e Lega Serie A, che si è concluso nel settembre 2025. L’obiettivo era capire come lo sport possa diventare davvero un luogo di inclusione, e non solo una parola da usare nei convegni.
Ho passato gli ultimi mesi a raccogliere storie che nessuno vuole sentire. Storie di arbitre che ascoltano insulti sessisti mentre cercano di dirigere una partita. Di ragazzi nati e cresciuti in Italia che non possono giocare per la nazionale perché il loro sangue non è quello “giusto”. Di atlete che ricevono un terzo dei fondi dei colleghi maschi e poi si sentono dire che lo sport femminile “non interessa a nessuno”.
Il report è stato pubblicato a fine settembre e non è una lista di episodi isolati. È la mappa di un sistema che funziona esattamente come è stato progettato: per escludere. Ma dentro quella mappa ci sono anche i luoghi dove qualcosa cambia — dove allenatori, arbitre, genitori e associazioni scelgono di fare dello sport un terreno di convivenza, non di gerarchia.
Quando pensiamo al razzismo nello sport italiano, ci vengono in mente i cori negli stadi di Serie A, le prime pagine dei giornali, le sospensioni temporanee delle partite. Poi ho parlato con una giovane arbitra che mi ha detto: «Ho visto più casi nei campionati giovanili che in quelli degli adulti».
Lì, lontano dai riflettori, succede di tutto. Un ragazzo insultato in campo con epiteti razzisti, ma l’arbitro non sente. Niente referto, niente sanzione, niente conseguenze. Il sistema della giustizia sportiva può intervenire solo se qualcuno riporta formalmente l’episodio. Tutto il resto semplicemente scompare.
Tra giugno 2021 e giugno 2022, l’Osservatorio Nazionale contro le Discriminazioni nello Sport ha documentato 211 episodi: il 93,6% aveva motivazioni etnico-razziali. Non è un’anomalia. È il modo in cui il razzismo strutturale italiano si manifesta quando indossa una maglia da calcio.
E qui arriviamo al cuore del problema: lo ius sanguinis. Puoi nascere a Milano, crescere a Torino, parlare solo italiano, ma se i tuoi genitori non hanno la cittadinanza italiana, tu non sei italiano. Nello sport esiste lo “ius soli sportivo” dal 2016, ma riguarda solo il tesseramento, non le nazionali. Il messaggio è chiaro: puoi giocare, ma non puoi davvero appartenere.
Le donne sono il 28,2% degli atleti tesserati. Le allenatrici sono il 20%. Le dirigenti il 15%. Solo 2 organizzazioni sportive su 77 riconosciute dal CONI hanno una presidente donna. Un dirigente sportivo me l’ha messa così: «Se per un campionato maschile si investe 10 e per uno femminile 3, quella è discriminazione».
Ma la discriminazione non sta solo nei numeri. Sta nel fatto che le arbitre fanno metà delle esperienze dei colleghi maschi. Che i media dedicano il 5% dello spazio allo sport femminile. Che quando le atlete vengono raccontate, spesso si parla del loro corpo o della loro vita privata, non delle loro prestazioni.
Ho intervistato donne che hanno dovuto lavorare il doppio per ottenere la metà del riconoscimento. Che si sono sentite chiedere se “ce la facevano davvero” a dirigere una partita. Che hanno celebrato piccole vittorie – come Maria Sole Ferrieri Caputi, prima arbitra in Serie A – sapendo che ogni passo avanti costa una fatica che i colleghi uomini non devono nemmeno immaginare.
 La ricerca S.I.M.O. – Sport Inclusion Modern Output, realizzata con il sostegno di Soroptimist International d’Italia, ha raccolto oltre 800 testimonianze di atlete attive ed ex atlete italiane, e restituisce un quadro preciso: nello sport femminile, la disparità non è un’impressione. È un sistema. La ricerca verrà presentata a Roma venerdì 7 novembre, in occasione del corso di formazione per i giornalisti, organizzato da Giulia Giornaliste e Ordine dei giornalisti, dal titolo "Donne, media, sport: genere e informazione sportiva". L'appuntamento è dalle 9.30 alle 13.30 in via Sommacampagna 19, sede dell'Ordine dei gironalisti. Dopo i saluti di Guido D’Ubaldo, presidente OdG Lazio, interverranno Antonella Bellutti; Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale Femminile di calcio; Mara Cinquepalmi, giornalista; Tiziano Pesce, presidente Uisp; Mimma Caligaris, vice presidente vicaria Ussi; Vittorio di Trapani, presidente Fnsi. Modera la giornalista Alessandra Mancuso.
La ricerca S.I.M.O. – Sport Inclusion Modern Output, realizzata con il sostegno di Soroptimist International d’Italia, ha raccolto oltre 800 testimonianze di atlete attive ed ex atlete italiane, e restituisce un quadro preciso: nello sport femminile, la disparità non è un’impressione. È un sistema. La ricerca verrà presentata a Roma venerdì 7 novembre, in occasione del corso di formazione per i giornalisti, organizzato da Giulia Giornaliste e Ordine dei giornalisti, dal titolo "Donne, media, sport: genere e informazione sportiva". L'appuntamento è dalle 9.30 alle 13.30 in via Sommacampagna 19, sede dell'Ordine dei gironalisti. Dopo i saluti di Guido D’Ubaldo, presidente OdG Lazio, interverranno Antonella Bellutti; Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale Femminile di calcio; Mara Cinquepalmi, giornalista; Tiziano Pesce, presidente Uisp; Mimma Caligaris, vice presidente vicaria Ussi; Vittorio di Trapani, presidente Fnsi. Modera la giornalista Alessandra Mancuso.
Solo l’11% delle persone con disabilità gravi sotto i 65 anni pratica sport. Gli uomini con disabilità praticano il doppio delle donne (15,4% contro 7,9%). Al Sud la percentuale crolla al 13%.
Ma c’è un’educatrice che mi ha raccontato qualcosa di diverso. Lavora con il metodo della danza inclusiva, dove corpi con e senza disabilità si muovono insieme, senza categorie. «L’obiettivo è mescolare abilità differenti, non creare laboratori “solo per disabili”», mi ha detto.
Nei suoi laboratori – alcuni tenuti anche in carcere – le persone si sono sentite «immediatamente uguali agli altri». Non perché la disabilità scompare magicamente, ma perché l’ambiente costruito intorno a loro non la trasforma in stigma.
Ciò che determina l’inclusione non è l’attività in sé, ma il contesto relazionale. E questo vale per tutte le forme di discriminazione.
Il 41% delle persone LGBT+ attive nello sport in Italia evita il coming out nei luoghi di allenamento. Quasi il 20% ha rinunciato completamente a praticare sport per paura. Tra le persone trans, la percentuale sale al 54%.
Quando devi nascondere chi sei per poter giocare, quello spazio non ti appartiene davvero. E quando l’invisibilità diventa l’unica strategia di sopravvivenza possibile, abbiamo fallito collettivamente.
Il progetto SIC! ha mostrato che il cambiamento è possibile, ma anche che non può dipendere da progetti a tempo. Ogni volta che un’iniziativa come questa finisce, resta una rete di persone motivate ma anche la sensazione che tutto dipenda dalla buona volontà dei singoli. È qui che sta la vera criticità: l’antidiscriminazione nello sport non può essere un capitolo accessorio, ma una parte strutturale delle politiche sportive, con risorse, continuità e riconoscimento istituzionale.
Abbiamo bisogno che ciò che oggi è “progetto” diventi politica pubblica. Che i presìdi antidiscriminazione non siano un’eccezione, ma una presenza stabile in ogni federazione, scuola o società sportiva. Perché l’inclusione non nasce dagli eventi, ma dagli ecosistemi che costruiamo ogni giorno: nei campi, negli spogliatoi, nei regolamenti e nelle mentalità.
Ho scritto questo report perché credo che lo sport possa essere uno spazio di convivenza e riconoscimento, non di esclusione. Ma per arrivarci dobbiamo smettere di trattare le discriminazioni come eccezioni individuali e iniziare a vederle per quello che sono: il risultato di scelte sistemiche che possiamo cambiare.
Ogni volta che un arbitro si forma per riconoscere il razzismo, che una società investe nello sport femminile o che un ambiente sportivo si costruisce sull’ascolto e non sulla competizione, stiamo scegliendo un altro tipo di sport.
E, insieme, un altro tipo di società.
Per chi vuole approfondire i dati e le storie citate in questo articolo, consiglio di leggere il report completo del progetto “SIC! – Sport, Integrazione, Coesione”, pubblicato da Uisp.