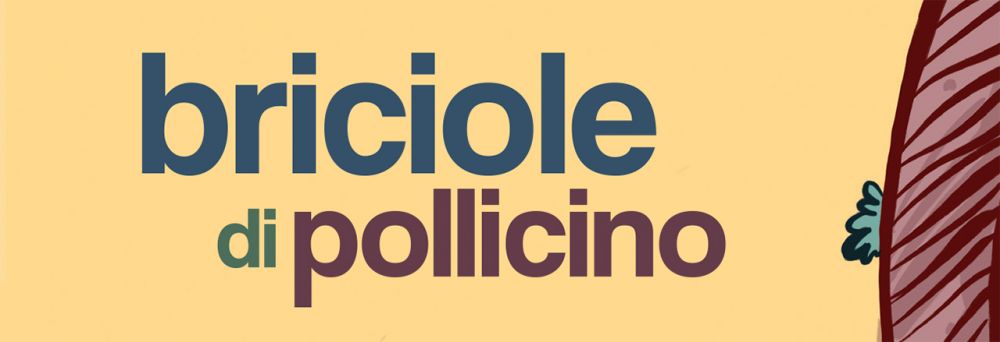Prassi e politiche ludiche
L'intreccio tra il gioco e le innovazioni sociali di un paese già multietnico. di Ivan Lisanti
di Ivan Lisanti
(da Area Uisp n. 11)
Tema del presente intervento è l'intreccio di prassi ludica e di politiche di sostegno al bisogno e/o al desiderio di attività ludiche e sportive di cui sono portatori i nuovi cittadini, con l'intento di fornire spunti metodologici e collegare prassi e politica dell'associazione, non sempre coerenti. Le pratiche ludiche di bambini ed adulti, prescindendo dal genere, possono essere analizzate interpretando le concrete condotte ludiche unitamente o disgiuntamente agli universali ludici della struttura del gioco, con l'ausilio di due specifiche prospettive: la prima strutturale, che ricerca gli elementi e le procedure comuni atemporali, la seconda regionale, che studia i tratti distintivi in un contesto socialmente e storicamente definito.
Premesso che in entrambi i casi si tratta di approcci multidisciplinari, definiamo il primo approccio "ontologia del gioco" o "ludosofia", avvalendoci prevalentemente di discipline quali la filosofia, la psicologia, la sociologia e la matematica, ed il secondo "etnologia dei giochi" o "etnoludicità", avvalendoci prevalentemente di discipline quali l'etnologia, l'antropologia, l'economia e la storia. In entrambi i casi dobbiamo considerare le relazioni della ludosofia e dell'etnoludicità con le scelte possibili o reali che condizionano l'immaginario o la pratica ludica, quindi con la politica dell'utopia o con la politica effettiva, espressione di una data comunità. Dobbiamo, da ultimo, interrogarci sul ruolo del gioco nelle civiltà umane, attraverso la comparazione di teorie e prassi ludiche e politiche di popoli e gruppi sociali.
Per mantenere un grado di generalità adeguatamente significativo, senza la caduta nel repertorio empirico dei giochi, dobbiamo partire dalla constatazione non confutabile che i giochi praticati dai popoli e/o in tempi diversi presentano sia caratteri simili che caratteri diversi. Per quanto riguarda le differenze ancora constatiamo che popoli e gruppi sociali si distinguono per uno o più dei seguenti elementi: lingua, religione, modi di produzione, usi e costumi nei quali rientrano anche i giochi, autoctoni o trasferiti da altre esperienze ludiche, appropriati in modo creativo o assunti in modo subalterno.
Spazi, tempi, numeri, regole e relazioni ludiche sono determinati socialmente da questo capitale simbolico e "prassico" ereditato, in divenire, soggetto all'influsso delle strutture materiali ed immateriali delle produzioni di figli, senso e merci, tanto a livello planetario che locale, senza le quali nessuna società umana potrebbe riprodursi nel presente e nel futuro.
Seguiamo la lezione di Parlebas che definisce l'etnomotricità "il campo e la natura delle pratiche motorie considerate nel loro rapporto con la cultura e l'ambiente sociale nel quale si sono sviluppate", definendo l'etnoludicità "il campo e la natura delle pratiche ludiche considerate nel loro rapporto con la cultura e l'ambiente sociale nel quale si sono sviluppate", distinguendo necessariamente tra pratiche motorie e ludiche, non sempre sovrapponibili, come nei casi di giochi praticabili senza attività motoria (i giochi-giochi proposti da De Toffoli).
Vero è che il corpo disciplinato, in movimento o statico, è sempre presente nella prassi ludica, ma il movimento ridotto alla motricità fine per muovere i pezzi di un tavoliere o mescolare un mazzo di carte, si distingue nettamente dalle pratiche motorie. Giochi del corpo e sport della mente sono più metafore che descrizioni o fatti ludici. Nei giochi-giochi si realizza una de-materializzazione dell'azione ludica corporea, una sua "mentalizzazione", che sussume tutte le operazioni sotto il controllo della mente del giocatore, in un teatro operativo fisicamente ridotto, reale o virtuale.
Tutti i giochi, comunque, motori e non, mantengono una simbolica, anche dopo l'avvenuta razionalizzazione in regole standard, eco delle loro remote origini sacre e di gesta di eroi eponimi, trasferiti dai racconti orali e da fonti letterarie scritte. Solo sotto la dominazione del modo di produzione capitalistico i giochi e le loro narrazioni assumono il ruolo di "merci universali" prodotte per un mercato globalizzato con regole standard, tradotte in più lingue, con un immaginario sintetico comune, per consumatori di tempo non occupato dalla produzione di valore. Tuttavia i giochi, in particolare quelli tradizionali, rimangono ancora oggi costitutivi dell'identità culturale di popoli e gruppi sociali di adulti anche all'estero.
Nelle società del primo mondo, il cui destino è l'identità plurale a causa del flusso di migrazioni internazionali mondiali e della decrescita demografica, non solo le lingue, religioni e usi e costumi sono presenti nella vita quotidiana delle metropoli e delle periferie, ma anche i giochi e gli sport. Parchi e giardini urbani pubblici sono popolati da nuove relazioni ed usi: partite di cricket e di tavla, musiche e danze, feste culinarie che irrompono nelle modalità d'uso autorizzate di spazi e tempi, confliggendo con leggi e regolamenti, comportamenti attesi e abitudini della popolazione autoctona. I giocatori sono in prevalenza adulti che trasferiscono le proprie abitudini e culture apprese in un altro contesto, mentre per i figli nati in Italia da cittadini stranieri è dubbio che conservino le medesime tradizioni ludiche e sportive della famiglia di origine; più probabile é che assumano le prassi ludiche dei loro coetanei, con i quali condividono l'esperienza scolastica. È nella scuola, pertanto, che la conoscenza e la pratica dei giochi, può diventare materia disciplinare per educare alla mondialità, alla conoscenza ed alla fratellanza con altri popoli e paesi.
L'Area del gioco promuove da tempo la conoscenza e le pratiche ludiche tradizionali del mondo, formando animatori ludici e organizzando tornei di giochi e sport di altre tradizioni, mentre tutta la Uisp accoglie nei propri campionati squadre e cittadini stranieri, adatta le proprie proposte sportive, motorie e ludiche agli usi e costumi dei nuovi cittadini, promuove manifestazioni sportive antirazziste frequentate da cittadini di diverse nazionalità. Le nostre proposte sono già da ora mediatrici tra culture sportive, ludiche e motorie: manca per il salto di qualità diventare soggetti di educazione ai diritti ed ai doveri di cittadinanza, promotori di mobilità sociale all'interno dell'organizzazione e di politiche di tutela dei diritti nelle istituzioni, con le proposte di politiche utopiche che prefigurino nuovi rapporti sociali ed effetti di merito sugli obiettivi e la destinazione di risorse pubbliche.
.png)









%20(5000%20%C3%97%201250%20px).jpg)