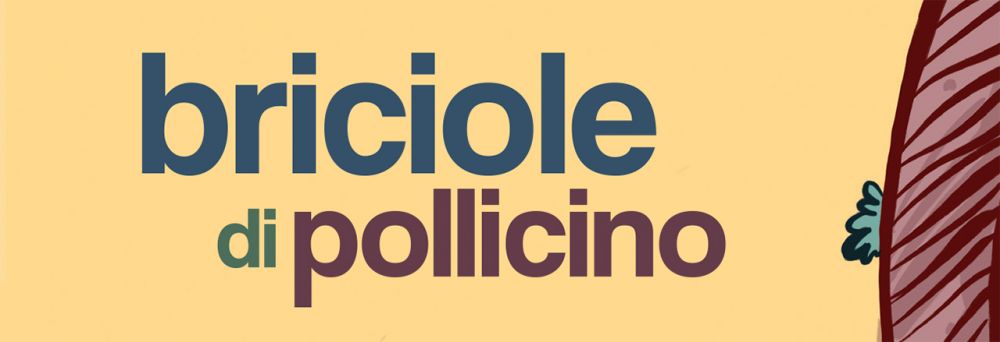Tracce di sport
Questo il nome del viaggio intrapreso nel 2010 e proseguito nel 2011 dall'ex pallavolista Andrea Zorzi e dalla ricercatrice Elena Donaggio. Dopo due anni in giro in camper alla scoperta delle più diverse realtà sportive del paese li abbiamo incontrati per sintetizzare la loro esperienza e conoscere il loro punto di vista sullo sport italiano di Vittorio Martone
di Vittorio Martone
guarda qui l'intervista in versione video
MILANO - Il fumettista Alan Moore, ricordando il ciclo di presentazioni del fumetto "V per Vendetta" scherzava sulla difficoltà di rispondere alla domanda del nervoso e ingenuo principiante, presente in ogni incontro con l'autore, che in una pausa della sessione "solleva in aria una mano e domanda, tremulo: 'Da dove prendi le tue idee?'". Mi metto nei panni del principiante tremulo e comincio con il chiedervi come nasce "Tracce di sport"?
E.D. "Il progetto parte da un'amicizia tra me e Andrea, nata fuori dell'ambiente professionale, che ha rappresentato anche l'incontro tra due professionalità diverse: Andrea non ha bisogno di presentazioni - ex pallavolista di successo, uomo di sport e giornalista sportivo -; io invece sono un architetto e da diversi anni ricercatore nell'ambito della pianificazione e dello sviluppo urbano. 'Tracce di sport' nasce da una serie di chiacchierate in cui cominciavamo a capire che c'erano due sguardi diversi per osservare lo stesso fenomeno, ovvero lo sport e, più in generale, l'attività motoria, il corpo, il movimento e la loro importanza nella società attuale. Il tutto si è innestato sulla passione comune del viaggio, dell'andare in giro, conoscere e guardare le cose più da vicino. È nata così l'idea di una ricerca esplorativa, sul campo, che provasse a conoscere più da vicino l'universo sportivo".
A.Z. "Il primissimo titolo del progetto era 'Lo sport ai tempi del calcio'. Nel 2010 c'erano i Mondiali in Sudafrica e l'idea era quella di girare per quaranta giorni, la durata della manifestazione, e vedere che ripercussioni avesse sul territorio un evento sportivo e catalizzante come il campionato del mondo. Abbiamo modellato sui 40 giorni il nostro viaggio in camper e siamo partiti, io, Elena e due fotografi che hanno fatto anche da operatori. L'idea era il piacere di viaggiare, di scoprire il paese, di vedere anche come lo sport cambiasse forma nelle varie aree. In Liguria ad esempio vedi la centralità della pallanuoto e puoi sentire raccontare da Eraldo Pizzo di come a Recco, dalle macerie, sia nato lo stadio del nuoto; a Jesi ti trovi a parlare con Stefano Celloni, allenatore della nazionale di scherma femminile, che racconta di come Triccoli avesse imparato la scherma in un campo di concentramento in Sudafrica per poi tornare e creare quella fornace di medaglie con cui, storicamente, ci difendiamo nonostante la mancanza di una cultura sportiva in questo paese. E qui faccio un inciso: conviene separare la questione delle medaglie ottenute dalla rappresentazione della sportività di un paese. Io sono felice delle medaglie, e penso che valga la pena investire molto per ottenerle, ma certamente è un modo un po' barbaro di pensare che la conquista delle medaglia equivalga alla presenza di una sportività diffusa. Detto ciò, questo primo viaggio era legato a portare a casa diverse fotografie per capire le nature diverse dello sport, senza legarsi solo al fenomeno del calcio".
Cosa ha spinto un uomo dal passato sportivo di appartenenza a una disciplina rigidamente  codificata e giocata ai massimi livelli a fare un viaggio all'interno del fenomeno sportivo nel suo complesso, guardando l'eccellenza e la base?
codificata e giocata ai massimi livelli a fare un viaggio all'interno del fenomeno sportivo nel suo complesso, guardando l'eccellenza e la base?
A.Z. "Il mio interesse a guardare allo sport in modo diverso è legato al fatto d'aver subito un po' anch'io, da atleta, lo stereotipo dell'appartenenza a una serie B sotto il profilo culturale. Per questo ho voluto provare a considerarmi giornalista. E l'incontro con Elena è stato straordinario perché mi ha invece proposto un altro approccio ancora. Lei infatti non era né affascinata né attratta dalla prestazione in se stessa o dall'idea della disciplina che invece a me piace molto. Sulle nostre differenze si è costruito 'Tracce di sport', che alla fine sta in questo continuo equilibrio, fragile, tra l'altro, perché le discussioni sono praticamente infinite. E questa è l'anima stessa del progetto: il fatto che a me piacciano alcuni aspetti prettamente sportivi come la qualità del gesto o l'organizzazione delle palestre e che ad Elena invece colpisca di più dove esse siano, quanto siano accessibili, come siano gestite. In alcuni casi tenere questo equilibrio ti assicuro che è impegnativo, faticoso ma anche molto affascinante".
Elena, qual è stato invece per te il collegamento che ti ha permesso di fare il salto da un settore disciplinare come quello dell'urbanistica a quello dello sport?
E.D. "Tutto il tema dello sport mi sembra riguardare la pianificazione delle città. E questo appare molto meno eccentrico se pensiamo che al centro ci sono le persone. Semplicemente lo sport è una delle tante attività che coinvolgono le persone nella loro vita quotidiana e a me interesse guardare alla loro interazione con lo spazio fisico, pensando allo spazio come supporto alle relazioni sociali". Parliamo allora di uso dello spazio. Nelle varie tappe del vostro viaggio avete discusso molto di impiantistica. Sono molto interessanti le tappe in cui emerge il tema dell'impiantistica spontanea, ovvero tutti quegli spazi non destinati originariamente all'attività motoria e che invece le persone utilizzano in questa funzione. Qual è la vostra visione al riguardo e come si muove l'urbanistica contemporanea rispetto a questi stimoli?
Parliamo allora di uso dello spazio. Nelle varie tappe del vostro viaggio avete discusso molto di impiantistica. Sono molto interessanti le tappe in cui emerge il tema dell'impiantistica spontanea, ovvero tutti quegli spazi non destinati originariamente all'attività motoria e che invece le persone utilizzano in questa funzione. Qual è la vostra visione al riguardo e come si muove l'urbanistica contemporanea rispetto a questi stimoli?
E.D. "Siamo in un paese in cui, nello sport come in altri ambiti, l'idea di sviluppo è sempre connessa alla presenza di infrastrutture. Tant'è che mille volte nel nostro viaggio abbiamo sentito dire che in Italia non c'è sviluppo della cultura sportiva perché mancano gli impianti. In realtà lacune e mancanze legate alla cultura sportiva non possono appellarsi a questa scusa. Noi abbiamo voluto smontare questo luogo comune, mettendo in evidenza le cose che si possono cominciare a fare senza attendere i grandi finanziamenti, le grandi infrastrutture etc. L'idea è quella di promuovere uno sport che possa diventare un momento quotidiano nella vita di tutti noi e che non necessariamente debba essere svolto dentro ad alcuni impianti. L'idea è dunque quella di utilizzare spazi pubblici, di natura diversa, che possono essere visti come luoghi per fare sport. Il lavoro da svolgere è favorire le diverse prospettive d'uso di questi luoghi e suggerire la pratica sportiva e motoria come una di esse. Rispetto al ruolo dell'urbanistica, credo che oggi ci sia l'opportunità di incentivare la percezione dello sport come una delle dotazione da tornare a dare in modo più diffuso alla città".
Andrea, vorrei parlare con te di sport destrutturati. Nella percezione comune le discipline "postmoderne" ti sembra siano percepite come degne di stare dentro il fenomeno sportivo?
A.Z. "Saremmo a cavallo se discutessimo in tal senso di parkour, giocoleria o hip hop. Il problema vero è che in tutte le coste italiane è vietato giocare a pallavolo, a basket, a calcio, perché forti interessi economici spingono a far fare attività motoria in spazi specifici. Dovremmo lavorare per avere spazi in cui fare attività a costi molto bassi o gratis. Invece non si gioca in strada, nei parchi, nei condomini e l'erba viene considerata qualcosa che non va calpestato perché si rovina. Io personalmente preferisco un prato un po' spelacchiato e vedere dei ragazzi che giocano a qualunque cosa piuttosto che un perfetto orto botanico. Ecco perché spazi spontanei, impianti spontanei. Tornare in qualche modo a pensare che questi sono luoghi che ci riguardano. E verificare le nostre aspettative rispetto agli spazi che abbiamo".
Credi che questo sistema di norme e divieti stia facendo venir meno la centralità del corpo  dell'individuo, vista la tendenza a immobilizzarlo e recintarlo anche quando lo si pensa nell'ambito dell'attività motoria? Ti chiedo questo anche in funzione di una vostra intervista a Gian Paolo Montali che in qualche modo apre una contraddizione con i dati Istat sullo sport al sud. Montali sottolineava infatti come nel meridione ci sia una motricità spontanea molto più sviluppata che al nord.
dell'individuo, vista la tendenza a immobilizzarlo e recintarlo anche quando lo si pensa nell'ambito dell'attività motoria? Ti chiedo questo anche in funzione di una vostra intervista a Gian Paolo Montali che in qualche modo apre una contraddizione con i dati Istat sullo sport al sud. Montali sottolineava infatti come nel meridione ci sia una motricità spontanea molto più sviluppata che al nord.
A.Z. "Parlare di motricità per come è intesa oggi ci sposta su un'area potenzialmente pericolosa. Motricità è sapersi muovere, sapere andare in giro senza sbattere contro i pali, alfabetizzazione motoria estremamente elementare? Definire con motricità quello che riguarda il nostro corpo vuol dire fare un'operazione culturale che io condivido solo parzialmente. La città moderna ha fatto sì che uno sia abile dal punto di vista motorio semplicemente se sa stare in piedi e camminare, senza riferimento alcuno al correre, ad esempio. Io sono cresciuto in campagna e penso a mio padre, che non ha mai fatto sport, attività motoria o esercizi di propriocezione, eppure l'idea che ho io di lui, del suo corpo, è assolutamente armonica. Il rischio è sempre quello di far diventare lo sport qualcosa di diverso dal rapporto molto naturale con il proprio corpo. Noi abbiamo usato l'immagine del triangolo, senza riferimenti alla piramide, immaginando il rapporto con il nostro corpo su tre estremi. In Italia c'è un vertice in alto in cui la gente ritiene che il corpo sia un involucro da modificare secondo principi estetici (chirurgia ma anche body building). C'è un altro angolo, al quale penso forse di appartenere anch'io, in cui il corpo è un mezzo per avere performance e prestazioni superiori. Poi c'è un angolo più basso (mi viene spontaneo piazzarlo lì) in cui si ritiene che il corpo abbia solo uno scopo, portare in giro la testa. Se questi sono i tre vertici, e questa ovviamente è un'esagerazione, mi piacerebbe che l'Italia si muovesse in mezzo ad essi. Credo non sia così attualmente. Quando si parla di sport, e questo è un altro dei riscontri di questo viaggio, non si prende in considerazione la normalità, la quotidianità del movimento. Lo sport, le attività motorie, non sono ancora una parte del quotidiano di ognuno".
"Sport & Cultura" è una delle tag più in vista nella cloud del vostro sito. Le statistiche Istat 2011 parlano di una situazione in cui dopo un sostanziale pareggio nel 2010 tra attivi e sedentari, oggi questi ultimi sono tornati maggioranza. E i dati ci collocano all'ultimo posto in Europa nelle classiche su pratica motoria e sportiva. Un rapporto che però non segnala o quantomeno trascura una forma differente di attività, legata agli sport postmoderni, fuori delle discipline ufficiali. Per cui, i dati che arrivano ad oggi, quanto sono veritieri e realmente indicativi della situazione del paese e quanto invece si basano su presupposti culturalmente arretrati rispetto alle realtà che ci sono invece in gioco?
E.D. "Tocchi una questione cruciale. Primo punto della questione è: come misuriamo lo sport, come identifichiamo le persone che fanno attività sportiva o che non la fanno? I dati disponibili fanno riferimento ai tesserati, a uno sport codificato o che si riconosce in discipline codificate. Questa fotografia è possibile grazie ai dati del Coni, delle Federazioni etc. e ci racconta di un paese che ancora in buona parte non si muove. Anche lì le fonti discordano molto a seconda della rilevazione, ma si potrebbe concludere che il dato riguarda più della metà della popolazione. Dall'altra parte sappiamo benissimo che ci sono moltissime persone che nella loro vita tutti i giorni si mettono le scarpe da tennis e vanno a correre o praticano una serie di discipline non codificate o per cui non è necessario tesserarsi. E quindi è come se esistesse tutto un mondo di sportivi invisibili che invece si muovono, fatto attività motoria e fanno sport ma non risultano in maniera ufficiale da nessuna parte. A questo problema si sta in parte cercando di porre soluzione - penso a molte Regioni impegnate nella costruzione di osservatori regionali sullo sport. Dall'altra parte credo che questo aspetto statistico sia interessante fino a un certo punto. Nel momento in cui infatti dalle politiche pubbliche c'è il riconoscimento di una domanda che arriva in forma spontanea da parte della cittadinanza, ritengo che le risposte possano passare anche al di fuori di un'identificazione statistica precisa ma attraverso la capacità di percepire che esiste una domanda a cui può essere interessante dare una risposta". Ritenete che il tema dell'assenza di cultura sportiva sia anche connesso al modello di gestione dello sport, che si basa sulla sostanziale delega da parte dello Stato al Coni? E viaggiando sul territorio, che deduzione avete tratto rispetto a questo problema, e che giudizio c'è in giro rispetto all'assenza di un assetto centralizzato forte con altrettanto forti deleghe ai territori?
Ritenete che il tema dell'assenza di cultura sportiva sia anche connesso al modello di gestione dello sport, che si basa sulla sostanziale delega da parte dello Stato al Coni? E viaggiando sul territorio, che deduzione avete tratto rispetto a questo problema, e che giudizio c'è in giro rispetto all'assenza di un assetto centralizzato forte con altrettanto forti deleghe ai territori?
E.D. "La questione di fondo è appunto l'assenza di un ministero e la presenza di un ente che, per delega, da sempre si è occupato della promozione dello sport dovendo muoversi su entrambi i fronti, ovvero vertice e base, finendo per fare molto meglio sul primo dei due e dimenticandosi della promozione più diffusa. Mi sembra di poter dire che moltissime voci dall'interno del mondo sportivo concordino con questa diagnosi. Noto che esiste una base estremamente sana, vivace e capace di supplire e auto-organizzarsi pur in mancanza di linee guida, di indirizzi e di politiche più chiare. Si ripete anche qui una condizione frequente in Italia: tutto ciò che si basa su un'organizzazione volontaria gode tutto sommato di una gran buona salute. In mancanza di qualcosa che indirizzi più chiaramente questa forte spinta che arriva dal basso, credo esista un rischio di sperpero. Moltissime persone infatti mettono a disposizione il proprio tempo in maniera volontaria. E la questione del volontariato, in molte interviste che abbiamo realizzato, poneva il tema del tipo di cultura motoria e sportiva che viene passata alle persone. È importante rileggere questo aspetto all'interno della definizione di sport che vogliamo dare. Sport di vertice e sport di base sono cose molto diverse che però possono stare insieme nella misura in cui una non esclude l'altra. La promozione dello sport di base che ad esempio la Uisp porta avanti e che ha notevoli ricadute sociali, in parte nel mondo sportivo codificato può far fatica ad essere compresa. Intanto sono anche da seguire gli studi che alcuni stanno portando avanti sull'idea sociologica di uomo che sta dietro lo sport, ad oggi in parte escludente e concentrata sull'alta prestazione".
A.Z. "Chiaro che alcuni sistemi sono migliori di altri, ma la differenza poi è connessa alla qualità delle persone che ci lavorano. Non credo che il ministero dello sport possa far cambiare la situazione italiana facendoci diventare improvvisamente un paese sportivamente evoluto. Al contempo non c'è dubbio che adesso vediamo quali siano i rischi del permanere di un sistema obsoleto. C'è chi dice in maniera provocatoria che, di fatto, il Coni è una specie di governo che non deve neanche affrontare le elezioni, e che però gestisce il mondo dello sport in Italia (un mondo tutt'altro che insignificante). In fatto di radicalizzazione, per me è stato molto interessante l'incontro con un ricercatore francese esperto di baskin il quale, presentando l'idea dello sport designed for all, faceva l'esempio di come è stata gestita la disabilità nelle scuole, ovvero con il canale della normalità e quello della disabilità, completamente separati e senza contatti. Due mondi che se li metti insieme forzatamente finisci col creare delle microesclusioni in una sorta di macroinclusione. Quale può essere allora una soluzione? Non negare una diversità, ma far sì che queste due realtà diverse si incrocino, abbiano punti di contatto. Allo stesso modo agonismo e dilettantismo, professionisti e amatori devono parlarsi, si deve fare in modo che ci siano alcuni luoghi in cui queste realtà si possano incrociare. E questo capita pochissime volte perché invece sono mondi concepiti come inconciliabili. Questo è pericoloso. Iniziamo invece a far fare le cose, 'corricchiare', sudare, toccarci, riempire i parchi pubblici e sentirli un po' più nostri, per sudare, perché quando sono sudato la mia testa ragiona in modo diverso. Il primo passo è iniziare a fare una qualcosa".
"Sport & Professionismo" è un'altra tag in grande evidenza nella vostra cloud. Si accennava  prima al tema di quanta professionalità ci sia nel mondo sportivo. Quanto è emerso questo argomento nel vostro viaggio e che considerazioni avete tratto invece rispetto alla legge sul professionismo sportivo, e quindi al riconoscimento dell'attività professionale per gli atleti?
prima al tema di quanta professionalità ci sia nel mondo sportivo. Quanto è emerso questo argomento nel vostro viaggio e che considerazioni avete tratto invece rispetto alla legge sul professionismo sportivo, e quindi al riconoscimento dell'attività professionale per gli atleti?
E.D. "Rispetto alla prima questione, ovvero l'assenza di professionalità specifiche anche nelle organizzazioni di base, questa da più parti è stata segnalata come una delle criticità maggiori. Il tema è legato in parte al fronte allenatori e alle capacità tecniche di preparazione, poi a quello gestionale, rispetto a società sportive più o meno piccole, disseminate a pioggia su tutto il territorio nazionale, in cui è spesso assente qualsiasi competenza di tale natura. Ma le lamentele al riguardo arrivano anche dalle istituzioni e dagli enti locali, che spesso faticano a trovare società sportive che facciano progetti un po' più sviluppati e in grado di fare rete. A proposito, l'impressione è che esistono moltissime risorse che però faticano a riconoscersi l'un l'altra come tali, a costruire istanze comuni e farsi promotrici anche di fronte a interlocutori sovra-locali tutti insieme come appartenenti al mondo dello sport. Sul tema del professionismo sportivo, penso alla testimonianza di Josefa Idem, che ci sottolineava l'enorme difficoltà nel pianificare l'enorme investimento per l'allenamento, che dipende sempre dal reperimento di sponsor e finanziamenti, pur essendo lei l'atleta che è, che continua a rappresentare un'enorme risorsa per il paese. E infatti quest'argomento mette in gioco la nostra grande anomalia, legata al fatto che molti atleti, di fatto professionisti, in questo paese devono fare riferimento ai corpi delle forze armate per avere uno stipendio".
A.Z. "In Italia c'è uno pseudo-professionismo, poiché solo calciatori, ciclisti, giocatori di basket sono legalmente riconosciuti. La cosa che mi spaventa è che facciamo finta di essere professionisti, costruire business plan sulle società e sul marketing del mondo sportivo senza avere la struttura. In Italia la stragrande maggioranza degli sport, pallavolo compresa, vivono principalmente sull'interesse più o meno temporaneo di alcuni appassionati, industriali di successo che hanno voglia di avere popolarità. Ben vengano, ma non possiamo parlare di sistema. Il calcio stesso in realtà non rende. Ci diciamo aziende ma non lo siamo fino in fondo, ecco perché c'è questa commistione strana di squadre di alto livello che si dicono professionistiche e poi vanno a chiedere il supporto delle istituzioni. Bada, non sto dicendo che una grande città o una regione debbano disinteressarsi di quella che è la squadra rappresentativa della zona, semplicemente tocca capire quale sia la relazione tra queste due entità. Se sei professionista vuol dire che hai una struttura che ti permette di reperire le risorse, l'istituzione può aiutarti ma non puoi permetterti di richiedere i vantaggi di un'associazione e poi dirti professionista". Si accennava prima alle teorie sullo sport. Nel descrivere il fenomeno, si è sempre fatto riferimento al modello della piramide: la base costituita dallo sport di cittadinanza (tag in maggior evidenza nella vostra cloud), la parte intermedia dell'agonismo e la punta dell'alta prestazione. L'idea di fondo dietro questa immagine è quella che dalla base ampia arrivino più sportivi al vertice e che, per contro, i successi del vertice producano ricadute positive su tutto il movimento. Un modello assolutamente contestato e in crisi cui lo studioso Jeroen Scheerder della Katholieke Universiteit di Leuven, in Belgio, contrappone l'immagine della cattedrale. C'è l'area davanti all'ingresso, quella dello sport amatoriale, in continuo scambio con quella successiva, posta davanti all'altare, dello sport competitivo. Poi c'è il campanile, completamente a sé, diviso in altre due parti: la più bassa, che è lo sport competitivo di alto livello, e poi la più alta, ovvero l'élite sportiva. Come giudicate il modello della piramide e che qual è la vostra idea hai su questa nuova descrizione?
Si accennava prima alle teorie sullo sport. Nel descrivere il fenomeno, si è sempre fatto riferimento al modello della piramide: la base costituita dallo sport di cittadinanza (tag in maggior evidenza nella vostra cloud), la parte intermedia dell'agonismo e la punta dell'alta prestazione. L'idea di fondo dietro questa immagine è quella che dalla base ampia arrivino più sportivi al vertice e che, per contro, i successi del vertice producano ricadute positive su tutto il movimento. Un modello assolutamente contestato e in crisi cui lo studioso Jeroen Scheerder della Katholieke Universiteit di Leuven, in Belgio, contrappone l'immagine della cattedrale. C'è l'area davanti all'ingresso, quella dello sport amatoriale, in continuo scambio con quella successiva, posta davanti all'altare, dello sport competitivo. Poi c'è il campanile, completamente a sé, diviso in altre due parti: la più bassa, che è lo sport competitivo di alto livello, e poi la più alta, ovvero l'élite sportiva. Come giudicate il modello della piramide e che qual è la vostra idea hai su questa nuova descrizione?
E.D. "È chiaro che il modello della piramide non considera che non esiste più una relazione diretta tra l'allargamento della base e il popolamento del vertice, oltre al fatto che le due questioni - promozione dello sport di base e individuazione di un'élite - necessitano di logiche e forme di investimento molto diverse. Il tipo d'investimento sul vertice, infatti, non può essere messo in relazione con quello per lo sport di base. Il modello cattedrale, che non conoscevo, descrive e individua meglio le relazioni rispetto a questa varie parti. Infatti la necessità è alimentare le attività legate allo sport amatoriale e competitivo, tra cui in effetti esiste un'osmosi e uno scambio frequente, per poi ragionare su altre forme d'investimento, come dicevo, a mano a mano che comincio a salire di livello. Personalmente però, se penso agli sviluppi, faccio fatica a non ragionare in termini di politica pubblica, e quindi in termini di lettura dei problemi specifici del sistema sportivo in vista della pianificazione di interventi, supporti e azioni in un mondo che ha problemi, risorse e realtà molto diverse".
A.Z. "Oltre al fatto che colpisce sentire che nella Uisp si citi uno studioso di un'università cattolica, il modello della cattedrale ci pone il problema della relazione tra le dimensioni della chiesa e quelle del campanile. Se no, in un paese campanilista come il nostro, si fa un campanile alto, alto, alto…"
E.D. "E a quel punto bisogna poi scegliere il modello: vuoi uno sport gotico, allora tutto proteso verso l'alto; vuoi uno sport romanico, e allora stai più allargato verso il basso (ridiamo, ndr)".
Avete chiuso la prima edizione di "Tracce di sport" alla manifestazione Uisp "Mondiali Antirazzisti". Ne è nata una riflessione sulla possibilità di considerare o meno lo sport in senso non competitivo. Fatta salva la dimensione competitiva in qualsiasi forma sportiva, foss'anche amatoriale, vorrei sapere qual è stato il giudizio su quella manifestazione di sport destrutturato.
A.Z. "Io ho due ricordi molto forti: uno è legato alla lunga chiacchierata con Filippo Fossati  (presidente nazionale Uisp, ndr), nella quale ci ha raccontato del modello della piramide che non funziona più; l'altro di questa scelta programmatica della Uisp di adattare lo sport alle esigenze dei praticanti cambiando le regole per renderlo aperto a tutti. Questo cozza un po' con il concetto agonistico nel quale ho vissuto. Altro tema forte di quella manifestazione, sul quale invece non c'è contraddizione e che mi piace molto, è l'idea di giocare a calcio senza arbitro, creando una situazione in cui o ci si mette d'accordo o non si gioca più. Io ho vissuto il mondo dello sport agonistico, mi sono divertito molto anche perché ho vinto molto, ma non ho mai giocato per divertimento e confesso che faccio fatica a uscire da una logica in cui la prestazione non sia parte integrante dello sport. Però voglio abbandonare la logica italiana della radicalizzazione di qualunque tema. È chiaro che una parte degli sportivi, che fanno attività per competizione, vorrà provare a vincere e farà tutto quello che è necessario - rispettando le regole - per raggiungere il risultato. Con disciplina, ordine, impegno. C'è chi giocherà per divertirsi di più, senza negare la parte integrante della competizione che ti spinge a fare un po' meglio. Personalmente tendo a pensare che coloro che si dichiarano in maniera convinta non competitivi lo siano principalmente perché hanno così tanto timore di non essere competitivi che preferiscono restare completamente fuori dal confronto. Al contrario c'è qualcuno, e io sono fra questi, che non riesce a vedere il mondo come nient'altro che una gara. Questo è particolarmente pericoloso: perché se in campo è accettabile e le regole sono fatte apposta per definire un vincitore, trasportare questa visione fuori dal campo di gioco diventa un po' complicato. Ma, ancora una volta, non si tratta di decidere chi abbia ragione. Il Coni, che ha come missione quella di far vincere le medaglie all'Italia, ha tentato di fare anche operazioni diverse non essendoci un ministero che si occupa del resto dello sport. Ma la natura stessa del Coni è legata a vincere e non si può cambiare. Ecco perché ci manca un pezzo di sport".
(presidente nazionale Uisp, ndr), nella quale ci ha raccontato del modello della piramide che non funziona più; l'altro di questa scelta programmatica della Uisp di adattare lo sport alle esigenze dei praticanti cambiando le regole per renderlo aperto a tutti. Questo cozza un po' con il concetto agonistico nel quale ho vissuto. Altro tema forte di quella manifestazione, sul quale invece non c'è contraddizione e che mi piace molto, è l'idea di giocare a calcio senza arbitro, creando una situazione in cui o ci si mette d'accordo o non si gioca più. Io ho vissuto il mondo dello sport agonistico, mi sono divertito molto anche perché ho vinto molto, ma non ho mai giocato per divertimento e confesso che faccio fatica a uscire da una logica in cui la prestazione non sia parte integrante dello sport. Però voglio abbandonare la logica italiana della radicalizzazione di qualunque tema. È chiaro che una parte degli sportivi, che fanno attività per competizione, vorrà provare a vincere e farà tutto quello che è necessario - rispettando le regole - per raggiungere il risultato. Con disciplina, ordine, impegno. C'è chi giocherà per divertirsi di più, senza negare la parte integrante della competizione che ti spinge a fare un po' meglio. Personalmente tendo a pensare che coloro che si dichiarano in maniera convinta non competitivi lo siano principalmente perché hanno così tanto timore di non essere competitivi che preferiscono restare completamente fuori dal confronto. Al contrario c'è qualcuno, e io sono fra questi, che non riesce a vedere il mondo come nient'altro che una gara. Questo è particolarmente pericoloso: perché se in campo è accettabile e le regole sono fatte apposta per definire un vincitore, trasportare questa visione fuori dal campo di gioco diventa un po' complicato. Ma, ancora una volta, non si tratta di decidere chi abbia ragione. Il Coni, che ha come missione quella di far vincere le medaglie all'Italia, ha tentato di fare anche operazioni diverse non essendoci un ministero che si occupa del resto dello sport. Ma la natura stessa del Coni è legata a vincere e non si può cambiare. Ecco perché ci manca un pezzo di sport".
Andrea, proprio in un'intervista rilasciata ai Mondiali Antirazzisti dicesti che in questo viaggio avevi percepito la mancanza di una rete in grado di mettere a sistema il mondo sportivo. Sono emerse ipotesi di sviluppo per crearla questa rete o senti che il mondo sportivo italiano è ancora diviso in compartimenti stagni?
A.Z. "Le Federazioni sono ancora dei silos, che si riconoscono gli uni gli altri perché fanno parte del Coni. Ma collaborano il meno possibile - a parole moltissimo - e tendono a pensare in proprio. È vero che le Federazioni non rappresentano l'intero arco dello sport. Ma lo stesso accade negli enti di promozione sportiva. La Uisp ad esempio si occupa di qualcosa che è legato molto al sociale, per cui la parte competitiva viene considerata un pezzo del vostro obiettivo. Per il Csi è più forte la componente educativa e religiosa. L'identificazione è forse inevitabile, ma non la separazione. Questo è un limite che abbiamo in Italia e dobbiamo superarlo".
.png)








%20(5000%20%C3%97%201250%20px).jpg)