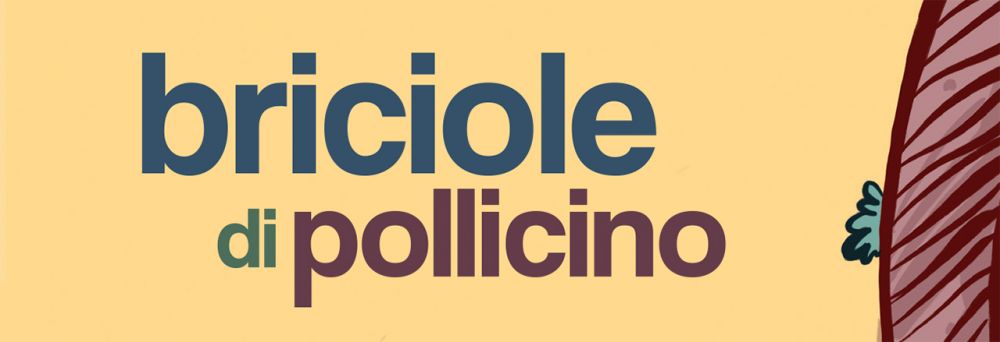La lunga onda degli ultras e la politica di controllo negli stadi
Un'intervista a Carlo Balestri, responsabile del Progetto Ultrà dell'Uisp Emilia Romagna, sui temi della tessera del tifoso, della politica di restrizioni contro le curve e del rinnovo degli impianti di calcio. di Vittorio Martone
di Vittorio Martone
BOLOGNA - Tifo e violenza, due modi di concepire il calcio che oramai sembrano essere sempre più sovrapposti e identificati l'uno con l'altro. Per tentare di fare chiarezza e fornire un punto di vista altro su questo mondo ancora oscuro a molti, così come per discutere della campagna di restrizioni e di criminalizzazione degli ultras avviata e sostenuta in maniera bipartisan, abbiamo intervistato Carlo Balestri, responsabile del Progetto Ultrà dell'Unione Italiana Sport Per tutti.
Proviamo innanzitutto a tracciare un quadro della storia del tifo in Italia.
"Si può far risalire la nascita di questo fenomeno ai primi anni '60, con le prime esperienze di tifo organizzato importate in Italia da Elenio Errera: gruppi che si organizzano per seguire la squadra e fare anche un po' di torcida la cui attività è però connotata da elementi molto tradizionali. Diversi e più innovativi sono invece i primi gruppi ultras che nascono verso la fine degli anni '60. Il primo a far propria questa nuova organizzazione, nel 1968, è la 'Fossa dei Leoni' del Milan, anche se i veri antesignani sono i membri del gruppo sampdoriano Tito Cucchiaroni. Gli ultras sono in generale animati da un nuovo modo di concepire la presenza allo stadio che ha origine in Gran Bretagna. È da lì infatti che si diffonde la moda di assistere agli incontri stando in piedi ed incitando ritmicamente la squadra e caratterizzando inoltre il proprio abbigliamento in maniera collettiva. Come per le bande giovanili, il territorio della curva viene quindi a essere concepito come inviolabile e si comincia a 'giocare' con gli avversari il rituale del conflitto. I giovani italiani assimilano questa tendenza inserendola nella propria realtà socio-culturale: un contesto caratterizzato da un altissimo conflitto e da una forte politicizzazione. Per questo in Italia i gruppi ultras si dotano di modalità organizzative e di contenuti molto più politicizzati, facenti riferimento per lo più all'ideologia di sinistra. Il gruppo ultras sin dal principio non rappresenta quindi solo un insieme di giovani ribelli ma anche una struttura organizzativa basata sulla solidarietà interna, su bisogni comunicativi e di creatività e sul principio della partecipazione. Per quanto riguarda invece la denominazione, essa deriva dal giornalismo, che associa a questi 'estremisti del tifo' l'immagine degli ultras della guerra di Algeria. Nonostante la connotazione negativa che il termine assume nei media, i tifosi con ironia se ne appropriano rapidamente e i primi a farlo sono appunto i supporters sampdoriani".
Quand'è che in Italia questo fenomeno comincia ad essere percepito come problema e fonte di pericolo?
"Direi che già all'inizio degli anni '70 ci sono dei chiari segnali di disagio che vengono fuori dalla stampa. È quello un periodo in cui peraltro aumentano gli incidenti durante le partite, tant'è che già nel 1975 la Figc decide di indire una giornata contro la violenza. Bisogna ricordare che già negli anni '60 capitava di assistere a risse o ad intemperanze anche gravi dei tifosi, dovute ad avvenimenti di gioco o a decisioni arbitrali, ma è con la diffusione dei gruppi ultras che si sviluppa anche una diversa modalità di violenza che in certi casi prescinde da quanto avviene in campo".
Qual è stato l'evento di cronaca che più di tutti ha cambiato la percezione delle persone verso il tifo organizzato?
"Sicuramente la morte di Vincenzo Paparelli, tifoso laziale ucciso durante un derby Lazio-Roma da un razzo lanciato dalla curva romanista, ha cambiato del tutto la percezione ed il modo di affrontare il tema della violenza. Direi che da quel momento gli ultras hanno cominciato a rappresentare un problema".
La virata verso una politica di repressione che segue questi avvenimenti è un fenomeno solo italiano o le esperienze straniere hanno comportato delle influenze?
"Direi che le esperienze europee hanno influito. Il problema di questa risposta esclusivamente repressiva sta però nel non aver tenuto conto delle specificità italiane del fenomeno ultras che impediscono di paragonarlo tout-court a quello hooligans. Qui da noi infatti la deriva violenta dei gruppi di tifo organizzato ha rappresentato solo una parte di tanti altri aspetti associativi. Diversità notevoli quindi dagli hooligans, che vivevano invece circoscritti nell'ottica dello scontro e in cui il massimo dell'organizzazione funzionava solo in termini di costituzione di gruppi paramilitari. Ciò nonostante questa è la via che si è intrapresa dal 1995 in poi e che ha visto un forte incremento dal 2001 ad oggi".
Prima accennavi al fare politica nelle tifoserie come naturale risposta alla situazione italiana degli anni '60 e '70. Oggi il tema delle "curve politicizzate" è al centro di numerosi dibattiti in cui non manca chi sostiene che la politicizzazione e lo schieramento a destra di molte tifoserie sia stato indotto. Qual è la tua opinione?
"Come dicevo i gruppi ultras si sono dati fin dal principio, sia nei nomi che nei simboli, una chiara connotazione politica. La divisione era netta: una stragrande maggioranza di gruppi schierati a sinistra e una minoranza ben radicata e consistente a destra, rappresentata dagli esempi storici di Verona, Lazio, Ascoli e Inter. Il fatto che oggi le adesioni a destra siano aumentate non può indurre a credere che questo sia frutto delle mosse di un 'grande fratello'. Sicuramente nel corso degli anni '90 ci sono stati tentativi di strumentalizzazione politica delle curve, tra cui il caso conclamato della Roma o quello del Padova (dove fino a poco tempo fa si distinguevano a fatica i tifosi della curva dagli iscritti a Forza Nuova), ma la situazione generale in realtà non è altro che il frutto di una più generale adesione di tutta la società a 'valori' di destra. Questa adesione, per fortuna, non sempre si traduce in militanza. Se così fosse, ogni volta che a Roma – città in cui entrambe le tifoserie sono schierate a destra – viene convocata una manifestazione di Forza Nuova, ci sarebbero per strada tra le 4 e le 5 mila persone anziché le cento attuali. Questo accade perché, anche se si condividono determinati ideali, allo stadio sei principalmente un gruppo ultras".
Hai parlato dei gruppi ultras come sede per la condivisione anche di percorsi di crescita collettiva. Sembra che oggi questa loro caratteristica non esista più e che le tifoserie affrontino una dura fase di disgregazione.
"Oltre che frutto della generale disgregazione sociale in atto questa è sicuramente la conseguenza di una repressione cieca ed emergenziale; una repressione che non fa distinzioni e non lavora per il cambiamento di mentalità ma si fonda sulla punizione generica e sulla criminalizzazione del tifo organizzato tout-court. Il principale risultato di questa politica è stato quello di creare scompensi nella struttura tradizionale del gruppo ultras che, pur annoverando la violenza come una delle opzioni a disposizione (cosa che un ultrà non rinnegherà mai), era comunque un luogo basato sul rispetto delle regole e di diversi meccanismi partecipativi. Quello che infatti non si conosce del gruppo ultras è la sua parte di vita associativa, con tanto di assemblee, riunioni, divisione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità, di organizzazione, di creatività e, non ultima, di solidarietà (con le numerose campagne, di cui abbiamo traccia anche nei nostri archivi, a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali oppure per il finanziamento di progetti in Africa oppure ancora per il telefono azzurro). Con gli interventi strutturati finora l'unica cosa che invece si è riusciti a scomporre è stata proprio tutta la parte positiva e propositiva. Si è indebolita la struttura, che può portare anche violenza, ma non si è eliminata la violenza, che essendo priva di regole è molto più facile da scatenare anche senza un'organizzazione alle spalle. In sostanza si è provveduto ad ostacolare tutte quelle modalità associative che potevano rappresentare il vero baluardo contro la violenza indiscriminata".
A proposito di rapporto con le tifoserie, in un'intervista del 21 agosto a Radio Anch'io Roberto  Massucci, segretario dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ha affermato che la "tessera del tifoso" sarebbe il primo passo per la realizzazione di un contatto con la componente del tifo che fino ad oggi è sempre mancata. Che idea hai al riguardo?
Massucci, segretario dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ha affermato che la "tessera del tifoso" sarebbe il primo passo per la realizzazione di un contatto con la componente del tifo che fino ad oggi è sempre mancata. Che idea hai al riguardo?
"Mi chiedo come si possa ritenere veritiera un'affermazione del genere. La tessera del tifoso infatti è in primis uno strumento che va ad aggiungere burocrazia a burocrazia per creare un rapporto tra società sportiva e tifoso che già esiste grazie all'abbonamento. La tessera in realtà serve poi a soddisfare due esigenze: da un lato quella del controllo totale di tutti i tifosi con una scrematura di coloro che negli ultimi cinque anni hanno compiuti atti violenti, dall'altro quella della soluzione del problema delle trasferte a rischio. In entrambi i casi, però, ci sono contraddizioni che fanno sì che questo provvedimento non abbia motivo di essere adottato".
Quali sono queste contraddizioni?
"Innanzitutto con la tessera del tifoso si inasprirebbe il divieto in cui si afferma che chiunque sia stato diffidato o condannato per reati da stadio non può entrare in possesso del biglietto. Qui c'è il paradosso di una legge restrittiva che non tiene conto della differenza tra la diffida e la condanna definitiva e non concepisce, inoltre, la 'redenzione'. Sul piano delle trasferte, invece, con l'idea di consentire l'accesso allo stadio a tutti coloro che sono in possesso della tessera del tifoso anche in caso di proibizioni dell'osservatorio per il settore ospiti, si finisce col non tener conto dei rischi relativi all'azione dei tifosi di casa o al contatto tra le tifoserie in altri settori dello stadio. C'è poi una cosa che non sempre mi è parso di vedere sottolineata, ovvero che la tessera del tifoso rappresenta, in quanto ulteriore strumento di fidelizzazione, un business. La tessera altro non è che una carta di credito prepagata, con tanto di Iban, che può essere addirittura utilizzata (con indicazioni al riguardo che arrivano direttamente dal sito dell'Osservatorio) per operazioni di pagamento fatture. Una carta che comporta dei costi di cui magari non si è nemmeno a conoscenza e che, sul piano economico, fa un favore alla banca e alle società sportive di prima fascia".
Nella direttiva Maroni del 18 agosto 2009 sulle disposizioni per la stagione calcistica 2009/2010 si parla molto della tessera come strumento di fidelizzazione tra società e tifoso più che come strumento di controllo. Ma allora qual è il senso di questa intromissione dello Stato in un rapporto che dovrebbe essere invece lasciato alla libera interpretazione di questi due soggetti?
"Questa direttiva è sicuramente frutto di scarsa competenza. Innanzitutto perché la tessera, nel progetto di governo, rappresenta un ulteriore mezzo per fare piazza pulita degli ultras e non considera che il modello di adesione ultras si basa su una cultura complessa che non sta solo nella curva. Questa sarà pertanto una battaglia persa che porterà via del tempo senza contribuire alla lotta alla violenza. Credo poi che tutte le norme vessatorie che sono state introdotte dal 2001 ad oggi fossero dirette all'adozione della tessera del tifoso, citata infatti per la prima volta proprio nel 2001. Questa formula era stata fatta propria dall'allora capo dell'Osservatorio Francesco Tagliente, che l'aveva ipotizzata prendendo qua e là spunti da diversi paesi europei e decontestualizzandoli completamente. Già da allora la tessera del tifoso si caratterizza come un intervento diretto dello stato in un rapporto che in tutti gli altri paesi si basa invece sull'accordo tra società e tifosi per ottenere vantaggi concreti in un regime di stadi tutti esauriti, dai costi elevati e in cui c'è overbooking. Ma la scarsa competenza è evidenziata anche dal fatto che le limitazioni poste dal governo prima della tessera, come il divieto di vendita nel settore ospiti nel giorno della partita e l'obbligo del biglietto nominativo con presentazione di un documento di identità, hanno creato l'allontanamento ancora maggiore delle persone che invece si vorrebbero portare allo stadio. Limitazioni che creano disagi tanto per il padre di famiglia quanto per il cosiddetto turismo sportivo. In questa onda lunga del controllo si è arrivati infine a questo provvedimento per avere una schedatura di massa di tutti ed eliminare chi nel corso degli ultimi vent'anni ha fatto violenza. Ma non si è considerato che c'è molta gente che ragiona con la propria testa e che rifiuterà di assoggettarsi a questa tessera, tra l'altro complicatissima da fare sul piano burocratico. Per cui questo provvedimento rischia di essere un flop o di essere gestito all'italiana con le consuete forme di pressapochismo".
Parli di scarsa competenza, eppure il ministro Maroni si ostina a sciorinare dati riguardanti il calo degli episodi di violenza negli ultimi anni.
"Beh, direi che la soluzione di non far più accedere agli stadi le tifoserie ospiti o di giocare le partite a porte chiuse ha sicuramente contribuito a non far verificare episodi di violenza. Ma la cosa è molto simile al chiudere a chiunque il passaggio nel centro storico di una città per impedire che ci siano scippi. Quella che noi viviamo ormai da tre anni è a tutti gli effetti una pianificazione restrittiva che non ha eguali in Europa e che si basa sull'interdizione come azione costante piuttosto che come intervento straordinario. Poi, non essendo il divieto a oltranza una soluzione, credo che dietro l'angolo continuino a esserci situazioni pronte ad esplodere, perché non essendoci stato un lavoro diverso dal controllo e dal divieto non è stato cambiato di una virgola l'atteggiamento che sottende a molti casi di violenza".
Al momento la tessera del tifoso ha un po' offuscato l'altro grande progetto nazionale per la soluzione agli episodi di violenza, vale a dire la costruzione dei famosi nuovi impianti polifunzionali. Che idea hai al riguardo?
"Credo che anche questo progetto sia in linea con il pensiero dominante, ovvero quello delle tre società sportive che comandano il calcio italiano. Di progetti faraonici sui nuovi impianti polifunzionali personalmente ne ho visti una marea: roba tirata su mettendo al lavoro per due giorni un architetto e che viene fatta per ottenere l'interesse dell'opinione pubblica ed il sostegno economico delle amministrazioni comunali, regionali e nazionali. Sono operazioni in cui nessuno vuole investire un euro ma in cui tutti sperano di guadagnare. E anche in questo caso, siamo in ritardo. Strutture del genere infatti potevano avere senso negli anni '90, con la nuova concezione dello spazio urbano e delle attività commerciali poste in situazioni dislocate: realtà che adesso sono già intasate e in perdita. L'idea degli stadi de-localizzati puzza quindi di speculazioni immobiliari da fare con il beneplacito delle amministrazioni, con cambiamenti di destinazione d'uso dei terreni da agricola a commerciale e traffici paralleli al limite della legalità. Personalmente credo invece che bisognerebbe pensare a una riqualificazione della prima periferia, magari con la riconversione e riprogrammazione di stadi che non siano fuori dal mondo e che interagiscano meglio con il quartiere. E penso poi a una riqualificazione che vada incontro alle esigenze dei tifosi, poiché credo che queste paradossalmente possano coincidere con quelle della società. Se infatti ci si sentisse a casa allo stadio, che oggi resta l'ultimo luogo significativo di aggregazione di massa, si realizzerebbe automaticamente la vera fidelizzazione. Quello di cui c'è bisogno è rendere gli stadi più accoglienti, con meno barriere, senza i fossati, con bagni un po' più degni di essere chiamati tali e con strutture ricettive realizzate rispondendo alle esigenze dei tifosi settore per settore. Io rivalorizzerei questi luoghi con un'architettura condivisa e accogliente, perché credo che l'allontanamento dagli stadi sia un frutto, più che della violenza, della difficoltà e della fatica che andare allo stadio comporta".
Il Progetto Ultrà lavora dal '95 per la difesa della cultura popolare del tifo e per la diffusione di valori positivi all'interno del mondo ultras. Quali prospettive ci sono in questa fase?
"Credo che ci siano due fronti. Da un lato l'impegno per creare su alcune realtà locali i presupposti di un rapporto chiaro e prolifico tra società e tifoserie e ricreare il concetto di comunità sportiva. Dall'altra, rispetto anche alla crisi del mondo del calcio sul piano economico, vorremmo cercare di sperimentare nuove forme di azionariato popolare, contribuendo a restituire il calcio ai tifosi anche da un punto di vista gestionale. Al momento abbiamo avviato degli studi e siamo in rete con l'organizzazione inglese Supporters Direct, che ha già avviato forme sperimentali in Germania di ingresso dei tifosi nei consigli di amministrazione di alcuni club. Credo sia giunto il momento di tentare simili esperimenti anche in Italia e ritengo che queste strade rappresentino davvero una soluzione ai problemi di cui abbiamo discusso. L'identità del gruppo ultras, infatti, è diventata lontana perché c'è una distanza siderale con quella che è la politica societaria. Lavorare per colmare questa distanza cercando di mediare tra le parti può portare a un'identità più condivisa, grazie alla quale e per amore di una ragione comune sia meno forte e meno sentito il germe della violenza e dell'intolleranza".
.png)








%20(5000%20%C3%97%201250%20px).jpg)