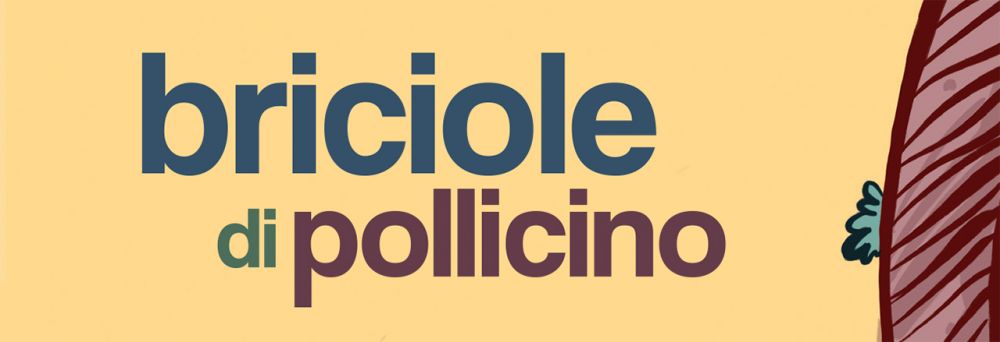Intervista a Venuste Niyongabo, olimpionico dei 5000m ad Atlanta '96
Venuste Niyongabo ci accoglie con cordialità. Ci colpisce subito la sua grande disponibilità e l'umiltà non comune in un ex campione olimpico, medaglia d'oro ad Atlanta 1996 nei 5000m, e primo campione olimpico in assoluto del suo paese, il Burundi. Venuste è in Italia dal 1992, prima a Siena e poi a Bologna dove vive con la sua famiglia..jpg)
di Alessia Malpensa e Michele Mele
Venuste Niyongabo ci accoglie con cordialità. Ci colpisce subito la sua grande disponibilità e l'umiltà non comune in un ex campione olimpico, medaglia d'oro ad Atlanta 1996 nei 5000m, e primo campione olimpico in assoluto del suo paese, il Burundi. Venuste è in Italia dal 1992, prima a Siena e poi a Bologna dove vive con la sua famiglia. Recentemente ha iniziato a collaborare con la Lega Atletica Uisp, dedicandosi in particolare a educare i più giovani, trasmettendo loro non solo le sue competenze tecniche ma anche e soprattutto la voglia di divertirsi e stare insieme. È anche responsabile del settore running di Nike Italy.
Come ti sei avvicinato alla realtà dell'Uisp?
"Io provengo da una realtà sportiva professionistica dove un elemento fondamentale è la capacità organizzativa; qui all'Uisp di Bologna ho ritrovato gli stessi principi e la stessa filosofia. Il mio interesse si concentra soprattutto sui giovani e sulle scuole: l'Uisp è una realtà molto attiva da questo punto di vista perché ha capito l'importanza dell'attività sportiva fin dall'infanzia. Una società sportiva per operare bene dovrebbe puntare soprattutto sulla crescita dei giovani mentre molti si accontentano di aumentare il numero di tesserati tra gli amatori. A dire la verità ho ricevuto molte richieste anche dagli amatori ma per me è tanto difficile lavorare con loro quanto è facile lavorare con i giovani".
Da quanto tempo collabori con l'Uisp e di cosa ti occupi?
"Io lavoro con i giovani della Lega Atletica da gennaio 2007 e, in particolare, seguo l'attività giovanile all'interno delle scuole. Sono convinto che, soprattutto quando i bambini sono piccoli, bisogna giocare e sperimentare le varie attività; poi il compito dell'educatore è quello di orientare il giovane sulla specialità in cui dimostra di avere più talento e dove trova maggiori stimoli. Da questo punto di vista anche i genitori svolgono un ruolo importante".
L'Uisp propone un modello di sportpertutti in contrapposizione al modello competitivo del professionismo. Perché un professionista come te si è avvicinato a questo mondo?
"Ho scelto l'Uisp perché pone al centro del suo interesse lo sport, indipendentemente dalla posizione politica. In tante altre società, soprattutto quelle legate al mondo militare, prevale la concorrenza, la competitività. Molti dirigenti puntano da subito ai risultati e chiedono agli atleti sacrifici troppo grandi. Invece prima si dovrebbe creare un ambiente sociale in cui si può passare il tempo divertendosi senza essere condizionati dalla prestazione e in questo l'Uisp si distingue da altre realtà".
Sono questi condizionamenti che portano all'abbandono di un'attività?
"Assolutamente sì. Molte società sportive spesso impongono il risultato anche ai bambini. Sono del parere che quando un bambino non ha più voglia di praticare uno sport, forse non è colpa dell'attività ma del fatto che non si trova bene nell'ambiente. Succede lo stesso a scuola quando un bambino non ha un buon rapporto con l'insegnante e non ha voglia di studiare una materia. Anche nello sport quando il bambino non è motivato o non ha un educatore credibile è molto facile che abbandoni. In quel caso dobbiamo essere noi a spronarli e ad essere creativi".
Qual è, secondo te, la principale differenza tra l'Uisp e il settore professionistico?
"La differenza fondamentale è il fatto che nel mondo del professionismo lo sport è visto come un mestiere. In alcuni casi gli educatori, non avendo vissuto la realtà del professionismo, non riescono a distinguere tra i due contesti e impostano l'attività dei bambini come se fosse un lavoro. Per i più giovani lo sport dovrebbe essere un divertimento e non un'imposizione come la scuola; crescendo, un giovane imparerà da solo se lo sport può diventare un lavoro. Il compito dell'educatore è quello di fargli capire quando ha raggiunto un certo livello di competitività, confrontando i suoi risultati con quelli degli atleti più preparati. Solo in quel momento, se si vuole emergere, lo sport deve diventare un lavoro che comporta, inevitabilmente, anche dei sacrifici".
Come hai capito che l'atletica era la tua strada?
"Io ho iniziato facendo sport a scuola ma non ho mai avuto un allenatore che mi ha imposto di praticare una certa attività. Ho scelto uno sport in cui ero più portato per essere selezionato e poter viaggiare. In seguito i risultati sono arrivati da soli, senza neanche saperlo. Sembrerà strano ma io non ho mai saputo che si potesse vivere facendo l'atletica, per me significava solo correre e viaggiare. Quando sono arrivato a livello nazionale sono stato selezionato per correre ai mondiali juniores in Corea del Sud, ma ho partecipato solo per capire fino a che punto potevo arrivare: lì ho vinto la medaglia d'argento e in quel momento è cambiato tutto, dalla strategia agli allenamenti. Quando vinci una medaglia, tutti ti conoscono e vogliono batterti, ma la cosa più importante per un atleta è migliorare se se stesso: si può anche arrivare ultimi ma fare il proprio personale. Invece, spesso molti atleti fanno gare tattiche, pensando solo al risultato, senza ottenere una soddisfazione personale".
Cosa ti ha lasciato la vittoria olimpica?
"La vittoria mi ha lasciato un bel ricordo soprattutto perché è stata frutto di un costante miglioramento personale. Inoltre mi ha dato anche l'opportunità di conoscere il mondo e di incontrare tante persone. Trovandoti a contatto diretto con i media, hai anche la possibilità di capire come va il mondo. Viaggiando molto, ho imparato a comunicare con gli altri e ritengo che questo sia molto importante al giorno d'oggi. Quello che conta veramente, anche quando si vince, è cercare di mantenersi umili, restando se stessi, senza diventare presuntuosi perché si rischia di non riuscire più a relazionarsi con gli altri".
Hai partecipato anche a Vivicittà, cosa pensi della manifestazione? Hai dei suggerimenti per migliorarla?
"La gara è bellissima ma non ha un'identità spiccata e soprattutto bisogna migliorare l'organizzazione interna e il livello dei servizi. Non c'è stata una distinzione netta tra la Strabologna e Vivicittà, ma so quanto è difficile il lavoro a monte svolto con il Comune: il livello delle pubbliche relazioni è stato ottimo, ma è mancata la presenza dei tecnici sul campo".
Il tuo successo ha contribuito a fare conoscere la realtà del Burundi?
"Purtroppo i tanti impegni non mi lasciano molto tempo a disposizione per dedicarmi al mio paese. Mi piacerebbe che in futuro nascesse un gemellaggio con il Burundi. Ad esempio anche nel corso di Vivicittà si potrebbero raccogliere dei fondi per finanziare lo sport nei paesi poveri: sarebbe un messaggio educativo molto utile e non servirebbero grandi spese. Un'altra idea potrebbe essere quella di istituire delle borse di studio per mandare i ragazzi all'università nelle nazioni più ricche: in questo modo potrebbero portare la loro esperienza nei luoghi d'origine".
Purtroppo anche nello sport ci sono ancora fenomeni di razzismo e problemi di integrazione. Hai mai vissuto situazioni simili? Come pensi che si potrebbero limitare?
"Io sono qua da 14 anni, non ho mai vissuto una vera forma di discriminazione; le battute ci sono ma bisogna aprirsi agli altri. Io ho girato molto per l'Italia, il razzismo che ho visto mi sembra più legato all'ignoranza e alla classe sociale perché nei ceti più bassi molti pensano che gli immigrati vengano a rubare il posto di lavoro. C'è molta generalizzazione anche a livello mediatico: quando c'è un atto di violenza si parla sempre di immigrati in senso generico mentre si dovrebbe identificare il responsabile di ogni azione; generalizzare significa seminare odio. Da parte nostra, non siamo qua per subire il razzismo ma, d'altronde, dobbiamo accettare di essere in un paese straniero. Dobbiamo essere noi i primi a far vedere quello che valiamo per integrarci meglio. Questo vale anche per un italiano che va all'estero: è necessario capire la cultura e la mentalità del paese in cui si vive e soprattutto è fondamentale imparare la lingua: per questo condivido la nuova proposta di legge che obbliga ad imparare l'italiano. Chi non sa comunicare è il primo ad essere oggetto di comportamenti intolleranti, invece se si conosce la lingua si può anche rispondere e tutto finisce lì. È importante essere ottimisti, tutto è risolvibile: anche in Italia ci sono forme di razzismo tra nord e sud o nella stessa città, mentre si tende a ingigantire il problema se sono coinvolti neri e bianchi. Io penso che se qualcuno mi guarda male perché sono nero il problema è suo, non mio".
.png)


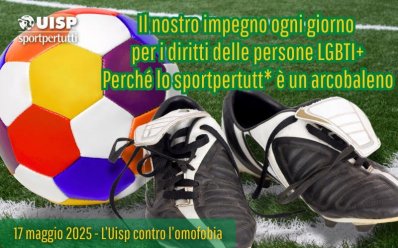








%20(5000%20%C3%97%201250%20px).jpg)