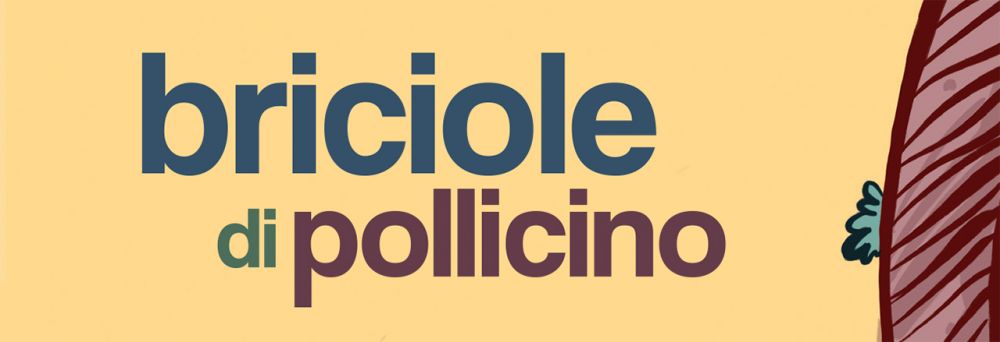Nell'area del gioco
Parte il percorso della Uisp per indagare l'ontologia delle attività ludiche. di Ivan Lisanti
di Ivan Lisanti
(da Area Uisp n. 10)
A Rimini il 7 e 8 novembre si è svolto un meeting sul gioco. Provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, dalle Marche, dal Lazio, dalla Campania e dalla Calabria, erano presenti 15 dei 17 esperti dell'Area Gioco Uisp, che comprende attualmente le collaborazioni tra Lega Sport e Giochi tradizionali e Lega Scacchi, coordinati dal sottoscritto in veste di responsabile della formazione e ricerca nazionale dell'Area. Il confronto sul gioco è iniziato in Emilia Romagna da diversi anni: partito con attività di formazione, ricerca e sperimentazione con il progetto di Lega "A che gioco giochiamo" nel 1998 è proseguito con il seminario dei ricercatori di Lega del 2007. Si è arricchito con le esperienze sul campo internazionale degli animatori ludico-sportivi della Lega Sport e Giochi tradizionali in Bosnia, Brasile e Palestina e va avanti con il sostegno al progetto nazionale della Uisp "Sub specie ludi", che ha tra i suoi obiettivi quello di proporre strumenti culturali utili a "fornire le basi comuni sul gioco ed elaborare una carta sul diritto al gioco per tutti conforme ai principi dello sportpertutti". Il programma del meeting ha avuto quali temi di confronto la "Ontologia del gioco", i tratti distintivi "Gioco e/o Sport", la casa comune della "Area del Gioco" ed i casi paradossali del poker sportivo e del soft air. Il dibattito ha risentito della diversa provenienza di animatori sportivi e ludici, con accenti diversi sui giochi motori (Ariemma) e i giochi (De Toffoli), come pure delle diverse referenze culturali: da Callois con il suo sistema classificatorio dei giochi in base alle quattro pulsioni ludiche agon, alea, mimicry, ilinx e Parlebas con la sua analisi dei giochi motori, sportivi, tradizionali e non a partire dalle relazioni interpersonali che si svolgono nell'azione ludica solitaria o cooperativa diadica e di gruppo.
L'interrogativo sui tratti distintivi tra gioco e sport ha avuto come esito l'accordo che giochi e sport hanno in comune, e la lingua italiana non ci aiuta, la struttura formata da: giocatori, le regole di funzionamento, i supporti materiali (attrezzature ludiche o sportive), l'azione ludica o sportiva. Tutti hanno condiviso che lo sport sia un sottoinsieme del gioco, ma possono entrambi mutare. Gli sport possono diventare attività motorie ludiche e non tutti i giochi restano giochi. Se è semplice classificare ed accogliere sport e giochi, antichi e moderni, delle nostre come delle altrui culture, come biliardo, scacchi, tavla, bocce, dodgeball, cricket in tutte le loro possibili varianti, che dire del poker sportivo e del softair?
Il poker sportivo comprende molti stili di gioco e risponde non solo alla pulsione dell'alea, ma a tutte le pulsioni individuate da Caillois. È dunque riduttivo definirlo unicamente un gioco d'azzardo. Il proibizionismo non ha mai funzionato in qualunque campo sociale, al contrario ha solo aumentato il numero delle violazioni. Si gioca di denaro? E negli altri giochi di carte, come ad esempio "Bestia", no? I praticanti se non avranno possibilità di giocare con noi giocheranno con altri. Come sempre è un problema di regolamentazione. Dobbiamo unicamente porci il problema se l'attività possa essere proposta con fini educativi. Dobbiamo fare giocare senza denaro o con puntate con tetti massimi? È opportuno affiliare sale da gioco?
Il softair, praticato da molti adolescenti ma gestito da adulti, ripropone gli stessi problemi sollevati per il poker, con in più quello dell'impianto in cui praticare la disciplina. La guerra simulata potrebbe essere condotta anche senza divise non mettendo in campo simboli evocativi di pesti del recente passato come il nazismo. Da un punto di vista educativo l'uccisione simulata potrebbe essere utilizzata come scarico dell'aggressività come nelle arti marziali e in ogni caso dobbiamo deporre la responsabilità e lasciare gestire la pulsione giovanile da adulti che potrebbero essere cattivi maestri? In entrambi i casi si tratta di ribaltare un immaginario sociale frutto di pregiudizi ideologici che vede discendere dalle attività in sé stesse comportamenti necessari e deterministici, dipendenti invece più dalla relazione educativa, dall'organizzazione e dal governo delle attività.
Infine, che cosa è il gioco? Si conviene che il gioco sia nell'ordine: libertà, divertimento, creatività, regola e socialità, diritto. Naturalmente i significanti hanno più significati, diverse aree semantiche dipendenti dalle culture di origine e dalle opzioni degli esperti ludosofi. Il gioco risulta all'analisi, come già lo sport, "merce indocile" (Missaglia). Il valore d'uso della parola nella circolazione linguistica veicola molti riferimenti culturali a volte anche opposti: dall'istinto ludico di uomini e animali a comportamento codificato appreso in ogni cultura. Ma se la natura continua nelle culture si giunge alla libertà come tratto distintivo dell'uomo (in tutte le culture) dal mondo animale, verificabile empiricamente nell'auto-riflessività umana, capace di ripensare e riprogrammare le proprie azioni, compresa la ripetizione ludica come scelta e non come destino. La libertà del giocare si contrappone alla costrizione del lavoro. il gioco è fine a sé stesso, non conosce il proprio esito ex ante, sospende il tempo quotidiano. È tempo fuori dal tempo, è investimento fantastico, immaginario, ma anche strumento di controllo sociale delle emozioni, delle relazioni e dei saperi di un dato tempo e di un certo luogo. Il gioco è tempo libero, comunque organizzato dalla produzione e dalla circolazione, o tempo liberato dalle logiche del lavoro e del consumo? Tempo libero e lavoro, piacere e denaro riguardano più la distinzione tra professionisti e amatori. Non si può escludere che entrambi provino piacere nella prassi sportiva e ludica, ma mentre per i primi l'azione è governata dalla prestazione obbligata e dallo scambio di forza lavoro contro salario, per i secondi l'attività si svolge nel proprio tempo libero, il più delle volte con dispendio del proprio stipendio in cambio del servizio svolto dagli erogatori.
Il meeting si è concluso individuando tre impegni: mantenere e sviluppare una comunicazione tra i ricercatori tramite un focus group destinato a condividere materiali sul gioco e gestito da Tatiana Olivieri, progettista nazionale dell'Area Gioco; segnalare o inviare testi e riviste da acquistare e mettere in rete nel Centro Documentazione nazionale Uisp di Bologna e in altri eventuali centri sul gioco; comunicare con soci ed associazione con una pagina cartacea su riviste Uisp di Comitati regionali e/o provinciali disponibili e sul giornale elettronico dell'Area.
.png)








%20(5000%20%C3%97%201250%20px).jpg)