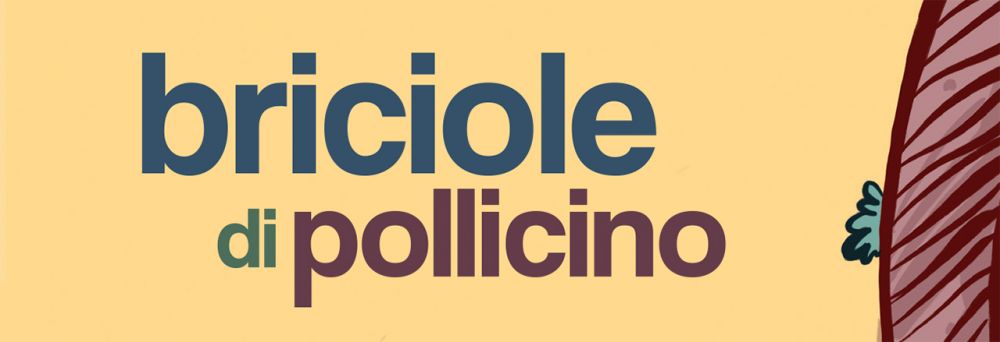Lo sguardo di Odisseo
Le tracce dell'intercultura nella storia dell'uomo. Per riscoprire il gioco come parte dell'identità personale di Ivan Lisanti
di Ivan Lisanti
da Area Uisp n. 15
LA MALINCONIA (melas-cholè, nera-bile) è uno dei quattro umori base che combinati in equilibrio tra loro, secondo il greco Ippocrate del V-IV secolo a.C., considerato tradizionalmente il padre della medicina scientifica, determinano il carattere e lo stato d'animo di un uomo. Per il filosofo Aristotele, IV secolo a.C., gli uomini che presentano un temperamento melanconico hanno la tendenza a vedere avvicendarsi nei loro stati umorali il senso di afflizione e il senso di euforia. La malinconia è quindi alla lettera uno stato di "umore nero", tuttavia non riconducibile, come suggerisce la sua etimologia, ad uno degli usi linguistici attuali che lo identifica con l'ira e la cattiva disposizione d'animo. La malinconia rimandava ed ancora rimanda invece al carattere introspettivo, allo stato d'animo autunnale, del dolore per un desiderio non del tutto compiuto o di una possibilità non completamente realizzata. Non a caso questo sentimento nel recente passato è stato, a torto o a ragione, attribuito alla filosofia esistenzialista, rappresentata iconograficamente in modo caricaturale dall'intellettuale di sinistra occhialuto, con il maglioncino nero a collo alto, in posa dolente, testimone del male di vivere.
La malinconia che ci accompagna dalla mattina alla sera come un vecchio rimorso o un vizio assurdo può essere letta insieme al suo sentimento gemello: la nostalgia. Con quest'ultima la malinconia condivide il senso di tristezza. Nostalgia infatti (nostos-algos, dolore del ritorno) rappresenta il rimpianto per la lontananza da persone o luoghi cari o per un evento collocato nel passato che si vorrebbe rivivere. Paradigmatico eroe della nostalgia è Odisseo, del quale si dice che "molti dolori patì sul mare nell'animo suo, per acquistare a sé la vita e il ritorno ai compagni". E oltre che sul mare, pene anche quando, prigioniero sull'isola Ogigia della ninfa Calipso, la nasconditrice, rifiuta l'offerta d'immortalità, invocando malinconicamente ogni giorno il ritorno a casa. Oppure ancora rifiutando il loto, dolcissimo frutto, che lenisce il dolore presente e consente di scordare il ritorno. Per sopravvivere fino al giorno del ritorno Odisseo sopporta di diventare "Nessuno", soffrendo melanconicamente i rischi di fallimento della fedeltà a compagni, famiglia, terra, onore, identità e lottando per preservare la sua memoria personale e collettiva, minacciata di sprofondare nell'oblio del piacere o nell'assenza di dolore delle droghe, in un eterno presente senza tempo, ricordi e possibilità.
Ma può un uomo assaporare il piacere di vivere senza il dolore, senza il ricordo, senza domandarsi come sarebbe stata la sua esistenza sulla terra bruna se avesse fatto altre scelte? Il poeta Schiller forse più di tutti ha capito il nesso sentimentale che lega malinconia e nostalgia: non si piange tanto il dolore presente quanto la convinzione che ci siano stati un tempo passato o un luogo migliori di quello presente o abitato. Si piange la loro perdita irreversibile come fatto o come occasione non colta, come rimpianto della felicità reale o immaginata. Ecco quindi spiegata la metafora autunnale "e noi come le foglie" che pervade la grande poesia da Omero a Quasimodo, passando per il mistico pellegrino della città celeste. Ecco quindi spiegato il sentimento che accompagna il viale del tramonto del divenire vecchi, il sentimento dello straniero presso l'altrui focolare che mangia pane che sa di sale, dello straniero in patria o dell'inattuale tra i contemporanei. Nei giochi, nelle danze, nei banchetti, nei canti passano i giorni felici dei Feaci e di Eolo, comunità chiuse, non a caso tutti parenti tra loro, dove Odisseo, ospite straniero, è costretto a raccontare più volte la sua storia, divertimento per gli uditori e tormento per la sua anima che anela, nostalgica, alla sua casa e, malinconica, a fantasticare sulle proprie esperienze. In entrambi i casi la cura dell'anima passa necessariamente attraverso il riacquisto del proprio vero nome in terra straniera.
Tutta l'intercultura è già presente nell'Odissea: usi e costumi e città di molti uomini vide e conobbe la mente, il rischio della perdita della propria identità e cultura e in definitiva della propria vita. Sì, di melanconia come di nostalgia si può morire, impazzendo da vivi quando, isolati e soli, senza compagni, non si conservi la propria identità nei piccoli riti quotidiani, come Alì, protagonista del film La paura mangia l'anima di Fassbinder. Quando ci sentiamo soli sempre ci salvano le piccole cose: il sapore dei cibi, la lingua madre nella quale sempre siamo due e i giochi delle nostre tradizioni, con la loro rassicurante ripetizione ed evocazione di sensazioni già vissute, nella consapevolezza odissiaca che non c'è gloria maggiore per l'uomo, finché vive, di quella che ci si procura con le mani e con i piedi. Quando insieme ci sentiamo parte di una comunità, reale o ideale, ci salvano le grandi speranze: nel mondo globale siamo tutti Odisseo, fratelli nella malinconia e nella nostalgia, formae animae comunque del vivere, ma anche nel riscatto del nostro nome, nella condivisione delle nostre pratiche ludiche e spirituali, dei nostri sogni, da scambiarci come doni ospitali, senza l'equivalenza oscena della merce.
.png)








%20(5000%20%C3%97%201250%20px).jpg)