Rom e Sinti: discriminazioni invisibili e barriere reali nello sport
“Don’t call me gipsy! Usa le parole giuste!”, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla cultura romanì e al contrasto all’antiziganismo
In occasione della Giornata internazionale di rom e sinti, celebrata l’8 aprile, Lega Serie A e UNAR hanno promosso per la prima volta una campagna di sensibilizzazione dedicata alla cultura romanì e al contrasto all’antiziganismo. Con il messaggio “Don’t call me gipsy! Usa le parole giuste!”, la campagna – lanciata durante la 31ª giornata di Campionato – ha puntato i riflettori sull’importanza del linguaggio e sulla necessità di superare stereotipi e pregiudizi nei confronti delle comunità rom, sinte e caminanti, anche nel mondo dello sport. Un messaggio che Uisp vuole amplificare nella sua attività di sensibilizzazione avviata dal progetto SIC!, promosso da Uisp, UNAR e Lega Serie A, per contrastare le discriminazioni nello sport e costruire spazi sportivi inclusivi, attivo 17 città italiane.
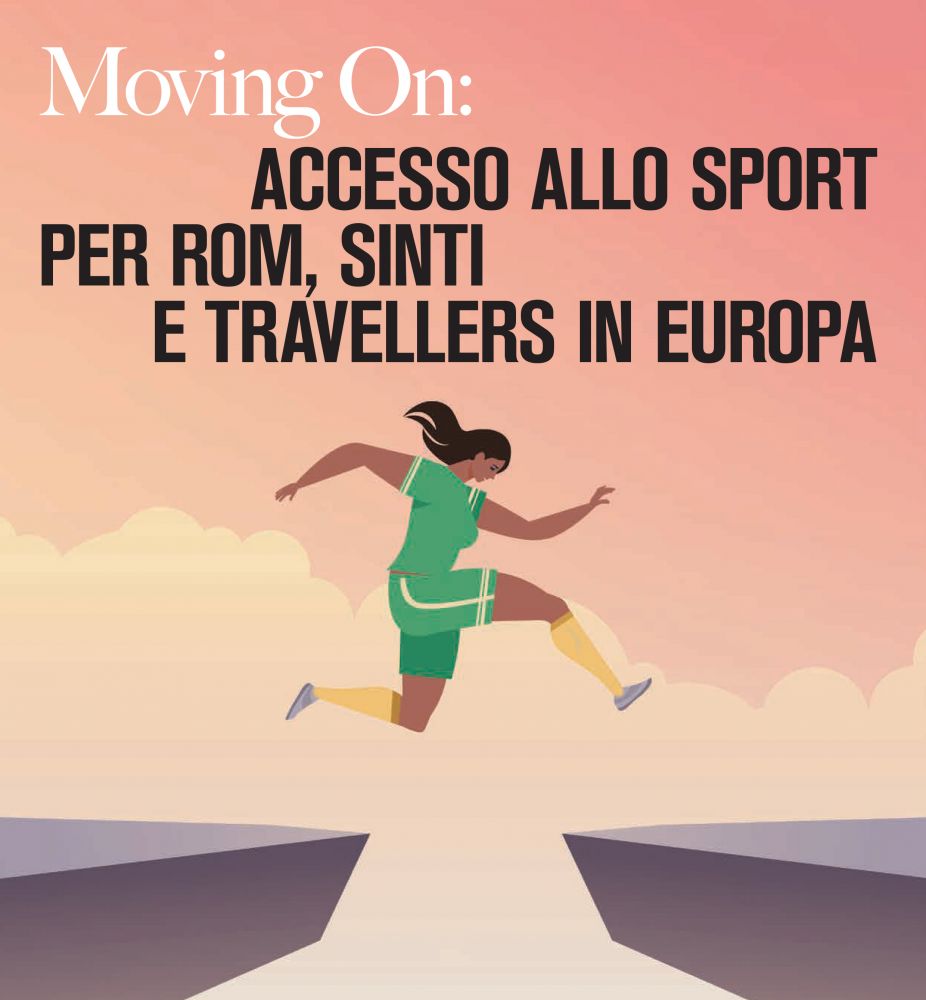 Secondo una recente ricerca pubblicata dal European Roma Rights Centre nell’ambito del progetto europeo Moving On, il razzismo strutturale nei confronti di Rom, Sinti e Travellers – identificato con il termine antiziganismo – rappresenta oggi uno dei principali ostacoli all’accesso allo sport. In Italia, come negli altri paesi europei coinvolti nello studio, lo sport si presenta spesso come uno spazio chiuso, dove le barriere economiche, sociali e culturali si intrecciano e si rafforzano. Le famiglie rom che vivono in insediamenti segregati (i cosiddetti “campi nomadi”), spesso privi di infrastrutture e servizi essenziali, non solo faticano ad accedere alle strutture sportive, ma si trovano di fronte a divieti impliciti e pratiche discriminatorie quotidiane.
Secondo una recente ricerca pubblicata dal European Roma Rights Centre nell’ambito del progetto europeo Moving On, il razzismo strutturale nei confronti di Rom, Sinti e Travellers – identificato con il termine antiziganismo – rappresenta oggi uno dei principali ostacoli all’accesso allo sport. In Italia, come negli altri paesi europei coinvolti nello studio, lo sport si presenta spesso come uno spazio chiuso, dove le barriere economiche, sociali e culturali si intrecciano e si rafforzano. Le famiglie rom che vivono in insediamenti segregati (i cosiddetti “campi nomadi”), spesso privi di infrastrutture e servizi essenziali, non solo faticano ad accedere alle strutture sportive, ma si trovano di fronte a divieti impliciti e pratiche discriminatorie quotidiane.
“Nei palazzetti dello sport non possiamo andare, nella palestra della scuola non possiamo andare. Ovunque abbiamo un divieto. Ai loro occhi quei bambini non lo meritano perchè magari non rispettano l’obbligo scolastico”, racconta un assistente sociale rom che allena bambini nel calcio. Un allenatore di calcio femminile di Padova spiega che le difficoltà sono accentuate dalla marginalizzazione abitativa: “Penso ai campi che sono vicino alle circonvallazioni e lontani dal centro città, dai servizi”. E queste sono solo alcune delle testimonianze raccolte nella ricerca.
La ricerca evidenzia inoltre l’assenza quasi totale di atleti e atlete rom visibili nei media o nei percorsi sportivi professionistici. “Abbiamo bisogno di ragazzi e ragazze che dicano: ‘Voglio essere il futuro Messi romanì’”, racconta una giovane donna intervistata in Spagna. Ma la paura di esporsi, di essere derisi, di subire atti d’odio impedisce spesso anche a chi ha talento di rendere pubblica la propria identità. “Vorresti metterti in mostra quando sai che c'è una forte possibilità di essere chiamato con epiteti offensivi?”, chiede retoricamente un giovane intervistato in Irlanda.
Il razzismo diretto, dunque, è solo una parte del problema. L’antiziganismo si manifesta anche sotto forma di povertà razzializzata, isolamento territoriale, assenza di riferimenti e modelli sportivi positivi. Le ragazze rom e travellers sono colpite da un doppio svantaggio, legato al genere e all’etnia: raramente incluse nei programmi sportivi locali, restano invisibili alle politiche pubbliche, anche a quelle con una dichiarata attenzione alla parità di genere
Tuttavia, la ricerca mostra anche alcune pratiche promettenti: le iniziative sportive nate all’interno delle comunità rom – spesso promosse da donne – si sono rivelate efficaci nel costruire reti di fiducia e partecipazione. Ad esempio, nei Paesi Baschi, una donna rom ha avviato un progetto che ha coinvolto atlete di diverse discipline – tra cui una campionessa di taekwondo, una giocatrice di basket e una ballerina professionista – per allenare altre donne rom della loro zona. L’iniziativa ha incluso anche momenti di formazione e dialogo, come pranzi comunitari aperti in cui si parlava liberamente del proprio rapporto con lo sport. Il progetto è cresciuto nel tempo fino a proporre attività come tennis, canoa, paddle surf, rugby Quando queste attività ricevono sostegno, dimostrano come lo sport possa davvero essere uno strumento potente contro la discriminazione e l’isolamento. Ma servono risorse, attenzione politica e una volontà esplicita di coinvolgere davvero chi è stato lasciato ai margini.
In questo senso, la campagna “Don’t call me gipsy!” rappresenta un primo passo importante. Ma affinché non resti solo un messaggio simbolico, è necessario che il mondo dello sport – dalle istituzioni ai club locali – si interroghi sulle proprie responsabilità. Come sottolinea anche SIC!, il contrasto alle discriminazioni nello sport non può limitarsi agli slogan: serve formazione, accessibilità, rappresentanza. Servono azioni concrete per rompere il silenzio e l’invisibilità che da troppo tempo circondano le persone rom, sinte e travellers anche nello sport. (Lorenzo Boffa)
Ufficio progetti - Sede Uisp Nazionale
L.go Nino Franchellucci, 73 00155 Roma
Tel.: +39.06.43984350 - 345 - 346
Fax: 06.43984320
e-mail: progetti@uisp.it









